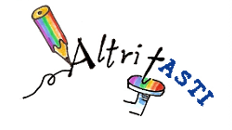di Marianna Filandri.
Il lavoro – dicono – c’è ma manca chi lo vuole fare. In Italia pare che gli imprenditori non abbiano proprio vita facile. I giovani nel migliore dei casi non sono qualificati, i disoccupati preferiscono sopra tutto stare sul divano e chi ha un lavoro sempre più spesso decide di lasciarlo. Quest’ultimo è il fenomeno noto come “la grande dimissione” o, in inglese, great resignation. In che cosa consiste, o consisterebbe? Nel fatto che lavoratrici e lavoratori lasciano volontariamente il proprio impiego perché insoddisfatti. A questo quadro si aggiunge il recente quiet quitting, ossia il darsi meno da fare sul luogo di lavoro. Dipendenti che decidono – senza scalpore – semplicemente di lavorare meno, “il giusto”, direbbero loro. Un “giusto” stabilito soggettivamente partendo dalla consapevolezza che il lavoro non definisce la propria identità. Di fronte a queste tendenze non stupisce che il nostro mercato del lavoro sia così in cattiva salute e la responsabilità dei problemi venga fatta cadere per lo più sul lato dell’offerta. La forza lavoro, sia essa occupata o meno, non si adopera a sufficienza per trovare un impiego e tanto meno per tenerlo o svolgerlo come dovrebbe...
Possiamo chiederci quali siano i dati su cui si basano queste retoriche regolarmente presenti sulle prime pagine dei nostri mezzi di informazione. A essere evocati sono quasi sempre casi singoli. Un ristoratore che cerca lavoratori ma non ne trova o un altro imprenditore che deve chiudere l’attività per mancanza di manodopera. Si può anche leggere di una coppia di sessantenni che si dimettono per partire in barca e fare un giro intorno al mondo. E ancora un ingegnere americano che, pur continuando a fare il proprio lavoro, dichiara di non volersi affaticare troppo. Queste situazioni, analizzate più approfonditamente, mostrano che spesso nella ricerca del personale le condizioni di lavoro offerte sono pessime, in alcuni episodi addirittura disoneste. Il caso di chi lascia il lavoro senza cercare un altro impiego riguarda persone vicine alla pensione o che possono contare su rendite patrimoniali. E quando si parla di quiet quitting si fa riferimento al fatto che i singoli si rifiutano di lavorare ben oltre l’orario di lavoro previsto, non rispondendo alle mail fuori dall’ufficio.
Vi sono anche dati statistici a supporto dello scenario descritto in queste narrazioni. Il primo è che in Italia ci sono circa due milioni di disoccupati e sono molte le imprese che cercano e non trovano. Il secondo è che il numero di dimissioni registrate, ossia le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente – dichiarate tramite comunicazione obbligatoria dalle imprese al Ministero del Lavoro – sono aumentate in termini rilevanti negli ultimi anni. Questi dati considerati singolarmente sono tuttavia fuorvianti se non inseriti in un contesto più generale di analisi. Ci limitiamo qui a ricordare solo alcuni aspetti.
In primo luogo, va considerato quali lavoratori cercano le imprese. Andando a vedere il dettaglio dei profili richiesti, si osserva che la maggior parte delle posizioni aperte riguarda mansioni poco qualificate, mentre la nostra forza lavoro è maggiormente qualificata. Questo dato è in linea con la struttura occupazionale del nostro paese che, secondo i dati Ocse, offre più posizioni a bassa qualificazione della media del resto dei paesi europei. Sostanzialmente in Italia abbiamo potenziali lavoratori con titoli di studio elevati che competono per posizioni poco qualificate. I dati ci dicono che circa quattro lavoratori su dieci sono sovra-qualificati per il lavoro che svolgono. Inoltre, è noto il fenomeno consistente dell’emigrazione all’estero di giovani qualificati.
In secondo luogo, va considerato che la distanza tra domanda e offerta di lavoro è un problema che riflette la debolezza dei centri per l’impiego. In Italia i servizi che dovrebbero dedicarsi a collocare efficacemente i lavoratori nelle imprese sono molto pochi e decisamente sottodimensionati. Le imprese non ricercano il proprio personale tramite i centri per l’impiego e chi cerca lavoro non lo trova per il loro tramite. Difficile quindi considerare veritiero che la colpa della disoccupazione e delle posizioni introvabili sia tutta della forza lavoro svogliata.
In terzo luogo, al dato sull’aumento del numero di dimissioni volontarie va affiancato quello delle nuove assunzioni. Quest’ultimo, secondo i dati ANPAL, è sempre superiore al numero di licenziamenti sia per il 2021 sia per il 2022. In altri termini le attivazioni di contratti superano le cessazioni. Questo non ci dice molto sulle scelte dei singoli, però è plausibile pensare che molti occupati si siano dimessi avendo trovato nuove occasioni nel mercato del lavoro, magari con condizioni migliori di qualifica, orario, stabilità, salario o magari di vicinanza a casa e clima organizzativo. Insomma, dietro al fenomeno della “grande dimissione” non vi sarebbe altro che movimenti di lavoratori da un’occupazione all’altra, e comunque sempre per una percentuale limitata (meno del 3,5% dei dipendenti). E ciò induce a chiedersi a chi possa giovare questa narrazione.
Questa domanda è rafforzata dalla presenza del tema del quiet quitting. Quest’ultimo è davvero poco sostenibile con dati statistici. Come sarebbe misurato l’impegno di lavoratrici e lavoratori nell’impresa? Come è definita la produttività? Se ci atteniamo a dati oggettivi cosa osserviamo? Dati sulla riduzione degli straordinari? L’orario di risposta alle mail dei dipendenti? In questi casi è evidente che gli straordinari non possono, per definizione, essere pretesi come se fossero parte dell’attività ordinaria e non lavorare fuori dall’orario di lavoro è non solo legittimo, ma anche giusto. Il problema qui non sono tanto i dati, ma l’idea che i dipendenti di un’impresa debbano sacrificarsi per il bene (profitto) del proprio datore di lavoro.
Se dunque questa narrazione è fuorviante, qual è l’alternativa? È quella di provare a presentare i problemi del mercato del lavoro senza ridurne la complessità, senza banalizzarli. L’alternativa è continuare a dare voce al lato della domanda di lavoro (a volte con un’informazione più completa), portando però all’attenzione pubblica anche quella dell’offerta. Un esempio tra i tanti riguarda certamente le condizioni occupazionali: la stabilità del lavoro, la sicurezza, la giusta retribuzione. Le difficoltà che vivono i nuclei precari suscitano meno empatia di quelle vissute da un imprenditore? Anche i feriti e i morti sul lavoro per mancanza di adeguate misure di sicurezza non meritano la prima pagina? E per quanto riguarda le retribuzioni, il fatto che ci siano occupati retribuiti meno di 6 euro lordi all’ora non è un problema da denunciare? Nel nostro paese non esiste una normativa sul salario minimo legale, la retribuzione sotto la quale per legge non si può scendere per pagare un lavoratore, indipendentemente dall’attività che deve svolgere. Su questo punto la Commissione Europea ha preso una posizione ben definita, spingendo tutti i paesi a garantire che lavoratori e lavoratrici siano adeguatamente retribuiti. Tuttavia, sembra che questo tema non riguardi l’agenda politica e neppure il dibattito pubblico. Speriamo che non sia così ancora per molto.
Tratto da: https://volerelaluna.it/lavoro/2023/02/13/chi-non-vuole-lavorare/