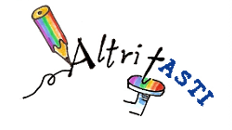Che cos’è il lavoro? Perché al giorno d’oggi esso viene essenzialmente retribuito sotto forma di salario? La risposta che siamo portati a dare è che il lavoro costituisce per eccellenza l’attività che ci permette non solo di guadagnarci da vivere, ma che ci conferisce anche uno status sociale rispettabile; inoltre, ci permette di acquisire dei diritti precisi (in termini di reddito, di previdenza e assistenza sanitaria, di accesso alla proprietà). In poche parole, oggi appare inconcepibile una separazione tra attività lavorativa, reddito, socializzazione, dignità, garanzie giuridiche e cittadinanza. Insomma, senza un lavoro l’uomo o la donna moderni restano socialmente indeterminati o fragili.
Che cos’è il lavoro? Perché al giorno d’oggi esso viene essenzialmente retribuito sotto forma di salario? La risposta che siamo portati a dare è che il lavoro costituisce per eccellenza l’attività che ci permette non solo di guadagnarci da vivere, ma che ci conferisce anche uno status sociale rispettabile; inoltre, ci permette di acquisire dei diritti precisi (in termini di reddito, di previdenza e assistenza sanitaria, di accesso alla proprietà). In poche parole, oggi appare inconcepibile una separazione tra attività lavorativa, reddito, socializzazione, dignità, garanzie giuridiche e cittadinanza. Insomma, senza un lavoro l’uomo o la donna moderni restano socialmente indeterminati o fragili.Peggio ancora, si sentono soggettivamente annullati. È per questo che perdere il proprio lavoro viene vissuto come un fallimento grave.
Una simile visione delle cose avrebbe probabilmente stupito molto gli uomini dell’antichità e non solo i filosofi.
Perché?
Per la ragione molto semplice che il lavoro non era percepito come elemento migliorativo della vita.
Al contrario.
Da numerosi testi apprendiamo che per i Greci (e così anche per i Romani) la vita buona, quella dell’uomo libero, era la vita consacrata alla cosa pubblica: alla polis in Grecia, alla res publica a Roma.
Essa presupponeva tempo a disposizione, reddito e soprattutto loisir: scholé in greco, otium in latino.
Si trattava, beninteso, di un ideale aristocratico, ma che era diffuso in tutta la società.
Chi non godeva dell’otium era nel neg-otium (il non-tempo-libero) da cui è derivato “negozio”, occupazione. Il commerciante era considerato l’individuo maggiormente impegnato nell’attività meno nobile; in altre parole, il commercio era quanto di più contrario alla vita buona.
In greco non esiste una parola precisa per designare il lavoro. Il termine ergon (dal quale viene ergonomia) designa piuttosto l’opera; più in generale, indica tutto ciò che si fa. L’attività di trasformazione viene indicata con il termine poeien, dal quale viene poeisis. Ogni artigiano ha una poeisis; con poêtès (poeta) si indicava chiunque creasse qualcosa, sia con le parole che con altri mezzi.
Quanto al contadino, come spiegano gli esperti di Grecia antica, non esegue un lavoro nel senso stretto del termine, poiché la sua attività non è nient’altro che la normale vita sulla terra; ara, semina, raccoglie, si prende cura della terra e delle piante.
Così è l’esistenza ordinaria; certamente non sarà la più invidiabile, ma per lo meno viene rispettata, anche se non le si attribuisce un termine che significhi “lavoro”.
Allora chi lavora?
Si può rispondere che a lavorare sono solo gli schiavi e ciò che fanno viene designato come pena. Sono uomini e donne di pena: nelle miniere, nei porti, nei trasporti, sulle triremi, nelle grandi tenute, nei servizi domestici.
Essi assicurano ogni sorta di servizi ritenuti indegni per dei cittadini, anche per quelli più poveri. Sono presenti in tutte le società antiche: è vero la schiavitù e il servaggio nelle società dell’Europa Occidentale sono scomparsi fin dal Medioevo, ma queste stesse società, pur dicendosi cristiane, non sono state turbate dal ritorno e dalla riaffermazione della schiavitù nelle loro colonie e nelle Americhe.
Tutti conosciamo questa storia ingloriosa. L’origine servile del lavoro compare nel francese travail o nello spagnolo trabajo; i due termini provengono dal basso-latino tripalium, che indica una forca di legno destinata ad appendervi uno schiavo punito o a immobilizzare un bue o un cavallo. In altre lingue la parola lavoro proviene dal verbo laborare. È il caso del lavoro italiano o del labor in inglese, che utilizza anche la parola work (opera).
Bisognerà aspettare la teologia cristiana e lo sviluppo delle città medievali a partire dal XII secolo per assistere a una rivalutazione del lavoro, non soltanto quello degli artigiani, ma anche (e con più reticenza) quello dei commercianti. Sappiamo che, nel pensiero cristiano, dopo la cacciata dal paradiso, ciascuno deve guadagnarsi il pane con il sudore della fronte.
La pena del lavoro non è riservata soltanto allo schiavo; essa fa parte della condizione umana. Tale valorizzazione si rafforza ulteriormente nel cristianesimo con il pensiero luterano, secondo il quale, essendo la grazia divina una decisione insondabile di Dio, il solo atteggiamento possibile del credente è, da una parte, la fede incondizionata e, dall’altra, una vita dedicata alle attività ordinarie dell’esistenza terrestre: il mestiere non è altro che la nostra vocazione; del resto, la parola tedesca Beruf indica allo stesso tempo l’una e l’altra. Ora, questa valorizzazione del lavoro conosce tra la fine del XVIII e quella del XIX secolo, un’amplificazione e un cambiamento paradossali.
Da una parte gli economisti come Smith, Ricardo e altri iniziano a proporre una visione distaccata, scientifica del lavoro, inteso innanzitutto come l’attività che produce ricchezza. Tale visione resta quantitativa, ma offre ugualmente una legittimità nuova.
La questione sarà tuttavia di sapere chi controlla questa ricchezza. Allo stesso tempo, con Hegel e i suoi eredi, si fa strada una valorizzazione di tutt’altro genere, che continua fino ai nostri giorni: è l’idea di lavoro come realizzazione e proiezione di sé nel mondo attraverso la mediazione delle cose. Lavorare è trasformare il mondo, farlo a propria immagine. Da questo punto di vista il lavoratore, alla fine del processo, ha la meglio sul padrone che ha goduto del lavoro altrui e che si ritrova estraneo in un mondo fatto senza di lui. Marx assume questa visione, ma vuole superarla con l’aiuto dell’analisi economica elaborata da Smith, Ricardo e molti altri.
Egli conferma che il lavoro è produttore di ricchezza, ne è perfino la fonte principale, ma questo plusvalore viene espropriato dal sistema capitalistico. Conosciamo bene questa analisi.
Ma Marx dice anche un’altra cosa ancora più interessante: ciò che viene captato dal capitale non è soltanto l’energia e la competenza, vale a dire una certa quantità di tempo del lavoro, ricompensata in modo insufficiente, ma è qualcosa di più, è ciò che lui chiama il lavoro vivente.
Che ne è del salario? La sua storia e le sue trasformazioni sono parallele a quelle del lavoro. Nell’Antichità e nel Medioevo un contadino si guadagna da vivere e dispone di poca liquidità; certo, gli artigiani e gli artisti sono ben inseriti nell’economia monetaria.
Lo stesso vale per i lavoratori occasionali o i soldati; salario indica all’origine la razione di sale che durante il Basso Impero serviva talvolta a pagarli. Ma l’idea che potesse esistere, come oggi, un reddito regolare offerto dal datore di lavoro, con delle garanzie a carico dello Stato, era qualcosa d’inconcepibile.
All’infuori del lavoro servile, che non viene retribuito in altro modo se non con il vitto e l’alloggio, per gli artigiani i redditi provengono da compensi occasionali e dalla vendita dei loro prodotti; per gli artisti provengono dagli onorari.
Rimane il fatto comunque che per noi oggi il salario appare come la migliore forma di retribuzione del lavoro, quella maggiormente in grado di essere giusta (anche se non lo è sempre) soprattutto perché questo denaro, la liquidità di cui disponiamo, ci permette di scegliere in cosa vogliamo trasformare il prodotto della nostra fatica.
Ricordiamo che lo schiavo non disponeva di alcun reddito monetario, dunque di nessuna autonomia nell’acquisizione dei beni e di nessuna possibilità di scambio. Egli non era insomma che un’estensione del corpo del suo padrone; il servo, invece, disponeva del diritto di scambiare qualche bene prodotto da sé; si tratta di un primo margine di libertà.
Il concetto di salario va oltre: significa che il mio lavoro viene trasformato in una quantità di denaro della quale io faccio ciò che voglio sul mercato dei beni scambiabili.
È un considerevole guadagno d’autonomia (anche se rimane il fatto che il salario può essere insufficiente). La storia del salario è formalmente la storia di un’emancipazione del lavoro umano.
Ciò è vero per qualsiasi tipo di lavoro: quello del dirigente d’azienda, così come quello degli operai, quello dei direttori di banca e dei loro dipendenti, quello degli uomini politici e dei funzionari. Vi sfugge solo la categoria dei ricchi ereditieri che decidono di vivere delle loro rendite.
Ma si tratta di una categoria rara.
Ci sono poi tutti coloro che continuano a percepire degli onorari. Chi sono? Cosa ne è degli insegnanti, ad esempio ? Rispondere a queste domande ci permetterà di avvicinarci alla soluzione del dilemma: mestiere o vocazione, dono o giustizia ?
Marcel Hénaff, filosofo e antropologo ha insegnato all’Università di Copenhagen e al Collège International de Philosophie di Parigi. Dal 1988 insegna all’Università di California a San Diego.
È autore de Il prezzo della verità, il dono, il denaro, la filosofia (Città Aperta Ed. 2007) che ha ottenuto, nel 2002, il prestigioso Gran Prix de Philosophie de l’Académie Française.
L'articolo è tratto da una Sua conferenza in Italia promossa dalla Cisl Scuola, i cui contenuti sono stati oggetto di lettura di uno degli incontri recenti dei “Giovedì della Parola” al Centro Culturale San Secondo di Asti.