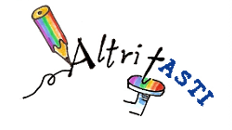di Francesco Ghia.
Dicono che per capire da quale zona provenga un piemontese sia sufficiente un piccolo esperimento: fargli recitare i primi versi di “Piemonte”, la poesia di Carducci che nessuno si sognerebbe di definire un capolavoro e che per lo più merita l’onore di una citazione per un memorabile sketch di un grandissimo Felice Andreasi che la declamava appunto in accentuata e solenne cadenza pedemontana ...
Basterà prestare orecchio a quanto stretta o larga siano la ‘o’ di «Piemonte» e la ‘e’ della «melodia mesta da lungi risonante» con cui scendono i fiumi, per indovinare immediatamente la denominazione di origine controllata e garantita dell’improvvisato declamatore: se sono strette, di sicuro costui proverrà dalla zona della «regal Torino», se sono medie, dalla zona della «Asti repubblicana», se sono larghe, dalla zona di «Cuneo possente e paziente»-
Quando Carducci compose la poesia correva l’anno 1898. All’epoca, il traforo ferroviario del Frejus aveva già compiuto 27 anni: era stato infatti inaugurato nel 1871, fortissimamente voluto, ai limiti dell’ossessione, da Cavour, che vedeva in esso una straordinaria occasione di espansione commerciale per l’Italia da lui immaginata, nonché la possibilità di realizzare una sorta di linea diretta che collegasse la sabauda e italica Torino con l’Alta Savoia francese.
Fin dalla sua istituzione, la linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane (via Bussoleno, Meana di Susa e Oulx) era quindi destinata ad assumere una valenza ben maggiore di quella attribuibile normalmente a una qualsiasi arteria di comunicazione: come poi noterà espressamente un frequentatore abituale di Meana di Susa, eletta a luogo ideale in cui recarsi a «cangiar fatica», ossia Benedetto Croce (al cui giudizio peraltro si deve anche la smisurata fortuna di Carducci nella storia della poesia italiana), quella linea ferroviaria assurgeva al rango di paradigma dell’orgoglio operoso del piemontese «popol bravo», a simbolo tangibile di ciò che può produrre, quando solo si metta di impegno, la volontà indomita della modernizzazione.
Le rughe di una vecchia signora e le seduzioni della giovane
A far da sfondo sullo schermo del mio computer c’è la foto di una montagna: è la punta Clotesse (2900 metri di altezza) delle Alpi Cozie settentrionali, nel cuore della catena della Grand’Hoche. Per me, che frequento l’alta Val di Susa fin da quando ero bambino, è la vera punta simbolo della valle: severa, con ampi tratti scoscesi e ripidi, con molto ciaplé (in italiano: ‘sfasciume’), ricorda il carattere montano degli autoctoni.
Taciturna, un po’ ruvida e aspra, in alcuni punti indisponente, ma comunque in grado di mantenere lealmente le promesse: la vista mozzafiato che si gode dalla punta (una panoramica sull’intera valle sottostante) è tale infatti da ripagare ogni sforzo fatto per ascendervi.
Il contenuto anche simbolico della tratta ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane e il carattere ruvido, ma leale dei valsusini sono, credo, due chiavi ermeneutiche irrinunciabili per provare a orizzontarsi un poco nella questione intricatissima della Tav. Nel seguito, vorrei provare a spiegarne il perché.
I valsusini amano la loro ferrovia. Per anni, soprattutto nell’Alta Valle, essa è stata tra le principali datrici di lavoro. Una ferrovia di altura (il traforo è a 1250 mt.) richiede infatti una manutenzione costante e accurata e una notevole quantità di ‘forza lavoro’. La qualifica di «manovale della ferrovia» era quindi tutt’altro che disprezzata, anzi ambìta, e veniva portata con tutto il legittimo orgoglio di chi sentiva su di sé la responsabilità di cooperare a un progetto importante.
Ma poi, «tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo», come constata il saggio e disincantato Qoèlet. Con il passare degli anni, la nobile e gloriosa ferrovia ha cominciato a subire l’onta del declino, come una bella donna di un tempo andato che ora si trova a fare i conti, allo specchio, con le rughe sempre più profonde e con i capelli sempre più bianchi. Le merci hanno cominciato a viaggiare viepiù su gomma (per effetto anche di politiche di agevolazione alla più grande fabbrica piemontese, produttrice di autoveicoli), la rotaia ha perduto di fascino, anche perché l’imbocco del traforo si era fatto troppo piccino per il passaggio di containers sempre più obesi e spigolosi. Da qui, la necessità di un nuovo traforo, questa volta stradale, e di una autostrada conseguente, la A32, per tir e per autovetture.
Che avrebbe tra l’altro favorito anche l’incrementato afflusso dei turisti dello sci e delle vacanze estive.
Malinconicamente, la vecchia ferrovia assisteva così al crescere abnorme dell’autostrada e del suo traffico di portatori insani di ossidi di carbonio e si rassegnava, con quel mix di ironia e mestizia che in fondo costantemente contraddistingue l’understatement piemontese, ai giorni un po’ grigi di una pur meritata pensione.
Ora, un uomo che abbia, nella sua gioventù, perdutamente amato una donna può anche accettare, forse, di vederla lasciarsi andare, con un po’ di triste trascuratezza, all’indifferenza dei giorni. Ma, se l’ha amata davvero, con onestà e lealtà, considererà il massimo della hybris, del tradimento e della mancanza di rispetto anche solo pensare di rimpiazzarla nel suo cuore con una donna più giovane, seducente e brillante. Così, il valsusino poteva forse ancora tollerare, se pure di malanimo, la proterva arroganza dell’autostrada e dei suoi tracotanti viadotti, con lo scempio ambientale e paesaggistico che essa recava con sé; ma sostituire la vecchia ferrovia con una nuova linea, più agile e snella, più scattante, veloce e charmante, questo no, era ed è un affronto inaccettabile all’orgoglio di chi è nato e cresciuto con la vecchia ferrovia.
Prima ancora che politiche, le ragioni dell’opposizione alla Tav sono dunque sentimentali. Cantano un inno alla lentezza, alle rughe e alla sapienza degli anni che invecchiano.
‘A sarà düra…
È il motto dei Notav: «sarà dura», la resistenza sarà continua e durevole. Non so come e da chi sia nato il motto e quanta consapevolezza lessicale vi sia alle sue spalle.
Certo tuttavia colpisce constatare come l’aggettivo ‘düra’ sia tradizionalmente legato, nel dialetto piemontese come in tanti altre dialetti, al lemma ‘vita’. A sarà düra ha quindi anche, e a mio avviso soprattutto, una valenza esistenziale: è la vita, nella concretezza della sua esistenza, a essere, e sempre permanere, dura…
Ignorarlo significa peccare semplicemente di ingenuità.
Ora, se c’è stata una Ursünde, un peccato d’origine nella gestione del dibattito sulla Tav, questa va probabilmente cercata proprio nel non essere stati in grado di comprendere, da parte di chi doveva gestire i processi decisionali, la natura autentica dell’opposizione. Fin dall’inizio, a leggere le varie tappe che hanno scandito gli oltre vent’anni di conflitto sul tema, i committenti politici dell’opera (governo centrale, Regione Piemonte e Provincia di Torino) hanno affrontato il dissenso con la convinzione di trovarsi di fronte un tipico caso di nimby («Not In My Back Yard», «non nel mio cortile»).
È ben comprensibile, si sono detti, che da parte di chi si vede espropriare un terreno, un orto, un giardino o addirittura una casa vi sia resistenza. È ben comprensibile, si sono detti, che i sindaci temano per l’impatto ambientale dell’opera e per la ricaduta negativa che tale impatto può avere sulla buona immagine (anche turistica) della loro comunità. Le prime discussioni con le controparti (e forse, sembra di capire, anche le attuali) sono state quindi improntate a un sostanziale paternalismo: «capiamo benissimo le vostre ragioni, che sono dettate dal fatto che non conoscete l’intera portata del progetto, ma quando le conoscerete non potrete che concordare con noi sul fatto che esso è stato pensato anche e soprattutto per il vostro bene…».
E allo stile pacato ma fermo del ‘buon padre di famiglia’ si è poi non di rado aggiunto il determinismo fatalistico delle decisioni sovraordinate da istanze inappellabili: «E poi, vedete, è l’Europa che ce lo chiede…».
Il modello paternalistico e deterministico-fatalista, ancorché praticato con una certa assiduità dalla comunicazione politica, è però ormai divenuto improponibile in un’epoca in cui l’accesso alle informazioni e lo scambio delle opinioni si è fatto, per chi voglia e possa, sempre più facile e rapido.
Occorrevano altre strategie, che implicassero una progettualità condivisa e non imposta, una discussione argomentata, e cifre alla mano, del rapporto costi-benefici, una seria programmazione di attività preventive contro le infiltrazioni mafiose che si annidano ogni volta che vi siano da realizzare opere mediante appalto. L’occasione è stata perduta, dando piuttosto l’impressione che l’esproprio di singoli terreni si espandesse a esproprio di un’intera valle, peraltro già ampiamente violentata nel passato da costruzione dell’autostrada, da cementificazione in totale assenza di qualsivoglia piano regolatore, e da opere faraoniche e mastodontiche erette in ossequio all’evento delle olimpiadi invernali di Torino 2006. Occorreva poi un argomentare convinto e convincente in ordine al fatto che un progressivo spostamento degli assi delle merci dalla gomma alla rotaia è fondamentale per un nuovo modello di sviluppo eco-compatibile Per contro, si è scelto di percorrere fino in fondo la strada della polarizzazione, a tutto vantaggio della comunicazione mediatica che di polarizzazioni vive e prospera. O sei pro-Tav o sei no-Tav, tertium non datur. O sei per l’ordine, per la modernizzazione e per il progresso, o sei per l’anarchia violenta, per la nostalgia del passato e per la scelta del declino.
La retorica ha fatto abilmente la sua parte nel cancellare ogni spazio alle sfumature intermedie e al dubbio dialogante di chi chiede, prima di assumere una posizione, di avere sott’occhio tutti gli strumenti necessari per crearsi autonomamente una opinione. Così molte domande attendono ancora risposta.
Tra queste: è davvero necessaria una linea ad alta velocità? Non bastava ammodernare la linea precedente? I costi non sono eccessivi? L’investimento è giustificato dalle attese di beneficio? Sarà poi davvero realizzata e resa funzionante l’autostrada ferroviaria, cioè l’obbligo per i tir di percorrere il tratto valsusino su rotaia, con considerevole beneficio per la qualità dell’aria? Quali sono i rischi reali dell’opera per la salute e per l’ambiente? Il Musiné, ossia la montagna con elevato contenuto di amianto e uranio, non fa più parte dell’attuale progetto (in origine, doveva essere traforato): ci sono però garanzie che amianto e uranio non siano ugualmente presenti nelle montagne che si vorrebbe ora traforare? ecc. ecc.
Il neopositivismo e la ginestra
Perché si sia giunti a questo punto è questione complessa che meriterebbe di essere approfondita a partire dalla ormai diffusa e pressoché generalizzata incapacità del potere politico di gestire i processi decisionali.
Abbiamo sì creato termini altisonanti come governance e decision-sharing, ma nessuno sa, nel concreto, che cosa vogliano effettivamente dire. La vaghezza definitoria si è così tradotta in vaghezza dell’azione, che affida il suo destino al parere di una categoria altrettanto vaga e indefinita, ossia quegli Esperti oggi consultati con la stessa voluttà e brama di conoscenza del futuro con cui gli antichi, prima di partire per la guerra, si rivolgevano agli oracoli (senza tuttavia mai in fondo capire se dalla guerra sarebbero tornati vivi o morti…).
Un verso di Robert Browning citato da Jorge Luis Borges nelle sue splendide lezioni americane sull’enigma della poesia dice: «Just when we’re safest, there’s a sunset-touch» («Proprio quando siamo più al sicuro, c’è un soffio di tramonto»).
Mi pare esprima lo stesso concetto dello «’a sarà düra» che fa da motto ai No-Tav. Si può essere d’accordo o non d’accordo con le loro ragioni. Ma se non altro la testardaggine implicita nel loro motto ci ricorda un insegnamento di vita: prima di accettare una qualsivoglia decisione occorre metterla alla prova, per cercare di capire se davvero è l’unica possibile.
Non è questo d’altronde l’atteggiamento più fedele all’etimo stesso del termine ‘decisione’, che richiama l’azione dello sfrondare un intrico da tutto ciò che è di impaccio, recidendolo?
Molti elementi inducono a ritenere che la società nella quale oggi viviamo assuma tratti che a buon diritto potrebbero essere connotati come ‘neopositivistici’. L’irrazionalismo dilagante in molte pratiche collettive (il culto degli oroscopi, la febbre del gioco, la fede cieca nei sondaggi, per non fare che tre esempi), lungi dall’essere una confutazione di questo ‘neopositivismo’, ne è il suo più verace correlato. In un numero sempre maggiore di àmbiti (dalla scienza alla economia) è tornata di gran moda, con tutto il carico delle sue seduzioni infide, l’idea delle «magnifiche sorti, e progressive». Il progresso inarrestabile procede e scorre, secondo l’immagine leopardiana, come la lava sulle pendici di un vulcano. Quando incontra sul suo cammino la ginestra, la travolge senza riguardo. E a quest’ultima non resta che, cristologicamente, piegare «sotto il fascio mortal non renitente» il suo «capo innocente»…
«O Freunde, nicht diese Töne», ovvero l’euristica della violenza
Nel suo studio del 1961 "L’io e gli altri " lo psicologo sociale Ronald Laing descrive con il termine «collusione» (dal latino cum-ludere, ‘giocare insieme’) il processo in base al quale la persona non desidera soltanto avere l’altro come appiglio per le proprie ineludibili proiezioni, ma si sforza di indurlo a diventare l’incarnazione della persona la cui collaborazione è
necessaria al completamento dell’identità particolare, ovvero del ruolo, che essa si sente costretta a sostenere e interpretare. È il meccanismo perverso del reciproco autoinganno nelle relazioni che bene abbiamo imparato a conoscere dalla dinamica televisiva del talk show: si prendono due posizioni contrapposte, le si ‘stressa’ fino a farle risultare irriducibili nella loro polarità e si fa in modo che i contraenti corrispondano in tutto e per tutto ai comportamenti attesi dalla formulazione delle loro rispettive posizioni. Se poi, in questa polarizzazione esasperata, scorre anche (letteralmente o metaforicamente) un po’ di sangue, beh, tanto meglio per l’audience…
Ormai, dietro la sigla Notav (quasi un brand, direbbero gli esperti di marketing) c’è qualcosa di più di un movimento locale di popolo. Si tratta quindi di capire chi decide realmente le strategie e che cosa ha in mente. Se si vuole il dialogo, la via non può certo essere quella di bloccare le strade, salire sui tralicci, invadere le stazioni bloccando i pendolari, tirare pietre, insultare o malmenare i giornalisti servi del regime, denigrare i poliziotti o i carabinieri (con modalità che tra l’altro sembrano ricordare la famosa denuncia di Pasolini contro i «figli di papà»).
Occorre non dimenticare che, nella rappresentazione pubblica del No-tav (e anche spesso nella sua collusiva auto-rappresentazione singola), costui è un antagonista che deve essere violento. E in effetti la violenza arriva. Ha un valore euristico, serve al Pro-tav per stigmatizzare il No-tav relegandolo nel cantuccio ben recintato riservato a individui pericolosi e dannosi con i quali non vale neanche la pena di provare a discutere e confrontarsi, e serve al No-tav per autenticarsi nella sua identità di antagonista, di lottatore duro e puro, ovvero, per dirla con Max Weber, di «etico dell’intenzione» che non si cura degli esiti a lungo periodo delle sue azioni (fiat iustitia, pereat mundus…).
Prima ancora che il processo venisse descritto in termini psicologici e sociologici, esso era già stato plasticamente illustrato da Beethoven in conclusione della Nona Sinfonia. L’orchestra è alla disperata ricerca di un tema. Ma non riesce a trovare un accordo. Si è polarizzata in due principi. Il principio normativo, incarnato dai suoni gravi e cupi dell’orchestra, e il principio orante, incarnato dal suono esile e timido dei singoli strumenti, le cui velleità vengono volta a volta stroncate e sopite dalla invadenza del principio normativo.
Da questa polarizzazione non può sortire alcunché di armonico. Deve intervenire un terzo, la voce baritonale dell’uomo che, rivolgendosi all’orchestra nella sua totalità, intima: «O Freunde, nicht diese Töne», «non è così, amici miei, che si suona». Solo adesso, prima sommessamente, poi in maniera sempre più vorticosa e coinvolgente, può partire l’Inno alla gioia che ridà fiato alla sinfonicità della composizione.
Nella controversia sulla Tav manca oggi questa voce baritonale. Che rappresenta l’unica possibilità per uscire dallo stallo, dall’impasse in cui la polarizzazione esasperata ha condotto i contraenti. Lo avevano già intuito Don Milani e i suoi ragazzi della scuola di Barbiana: «Allora facciamo così: abbandoniamo noi e Lei le posizioni troppo passionali e scendiamo sul terreno scientifico. Riprendiamo il nostro racconto da capo, ma questa volta in cifre». Perché quella della Tav non sia solo una melodia mesta, ma si trasformi in una possibilità sinfonica, occorre questa ripartenza dalle cifre, dall’analisi spassionata della situazione. Forse si è ancora in tempo per prevenire l’insorgenza di danni più gravi.
L'articolo originale è stato pubblicato sul numero di Marzo 2012 della rivista "Il margine".