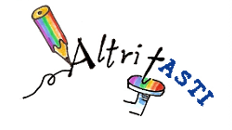di Anna Maria Dadomo.
In attesa dell’autobus si girò verso l’antica villa che sorgeva alla fine del viale dei carpini: parte della facciata, di un giallo scolorito, e le imposte verdi di alcune finestre si scorgevano appena attraverso la fitta vegetazione che l’accerchiava.
Anche l’orto era stato inghiottito ormai del tutto dalle piante selvatiche ...
Quando, per uscire, gli era passata vicino a stento ne aveva ritrovato il perimetro: le reti che lo delimitavano erano piegate, i paletti divelti o spezzati,l’interno abbandonato alla velocità dei germogli, dei rovi, dei rampicanti. Si ricordò di quanto le piacesse andare nell’orto. Di come spesso, pur di visitarlo, si inventasse il bisogno di un mazzetto di prezzemolo, di un porro, di un cespo di lattuga.
Spinta la fragile porta di legno le si apriva davanti un luogo magico, incantato. Anche quando il contadino che lo curava ne era diventato geloso, e per tenerla lontana si era inventato la storia di una lunga biscia che si nascondeva in mezzo alla verdura, lei non si era fatta intimidire.
Non appena lo vedeva allontanarsi in bicicletta lungo lo stradello, ci entrava di soppiatto e, anche se il più delle volte non prendeva niente , se non una foglia di basilico da fiutare mentre tornava a casa, provava un piacere indefinibile a camminare tra i riquadri ben ordinati, incantata ad ogni passo dal trionfo degli ortaggi. Poi, morto il contadino e di lì a poco anche la proprietaria della villa e del podere, tutto era caduto in abbandono. Ogni cosa, casa giardino orto vigneto parco, era divenuta preda delle piante, della loro spontanea, incontrollata vitalità vegetale.
Solo pochi giorni prima era andata per i campi incolti. Camminava a fatica, affondando nel terreno umido di pioggia. Il fango si appiccicava alle suole degli stivali quasi volesse trattenerla. Si respirava un buon odore di umidità, di terra, di foglie secche che marcivano, di erba che cresceva tra trionfi di cardi alti e pungenti. Il vento che arrivava giù dagli abeti del parco a ondate fresche e odorose e l’investiva, le strappava un sorriso.
Quando un corvo o una gazza, gracchiando in volo sopra la sua testa, planavano in quella desolazione e si nascondevano alla sua vista, nasceva in lei, subitaneo e contraddittorio, un sentire doloroso e felice insieme da finis terrae che la paralizzava.
Si fermava. Alzava la testa. Oltre quelle siepi irregolari, quel folto d’erba che riempiva i canali, quei pioppi lunghi lunghi che in lontananza definivano il podere non poteva andare. Non voleva andare. Che andassero le nuvole, che andassero loro oltre i filari inselvatichiti dell’uva fragola, oltre la barriera delle gaggie, oltre i noci imbastarditi, i platani scomposti. Quello che c’era al di là, città, mari, oceani, isole incantate, non la riguardava. Non le interessava più. Quel posto, il posto dove abitava,era magnifico. Era un piacere senza pari abitare quella casa, vivere quel giardino senza giardiniere. Lì aveva tutto di cui avesse bisogno. Di più.
Le sue radici affondavano in quella terra, si abbeveravano alla sorgente di quell’acqua sotterranea. Il suo sangue era vegetale. La sua pelle era vegetale. Succo di erbe la sua saliva.
Come potevano non accorgersi di questo le persone intorno a lei ? Da lì, non se ne sarebbe mai andata. Neanche da morta. Che il figlio spargesse le sue ceneri dietro le magnolie dove, da sempre, si seppellivano i cani e i gatti di casa che morivano.
Quello era il suo posto. Quando l’autobus arrivò lei non si mosse, lo sguardo fisso al cancello della villa.
Tratto da: http://www.annamariadadomo.it