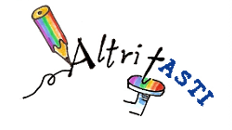di Silvia Pio.
di Silvia Pio.
In seguito all'atto vandalico verso la casa a Mondovì che fu di Lidia Rolfi, e alla immediata reazione popolare di protesta, mi permetto di pubblicare una mia intervista a Lidia.
La incontrai nei primi anni 80 ad Alba durante la presentazione del suo libro "Le donne di Ravensbrück". Questa intervista, però, risale esattamente a due anni fa, e per questo l'ho chiamata 'impossibile' (Lidia è mancata nel 1996). Su Margutte si trovano molti altri articoli a suo riguardo...
Sei nata e vissuta a Mondovì, come molti dei Marguttiani, vero?
Sì, e conoscevo anche alcuni di loro, li ho incontrati alla fine degli anni ’60 tra i ragazzi più giovani del movimento studentesco. Ci vedevamo nel mio laboratorio di pelletteria in via Giardini…
Lo sai che hanno dato il tuo nome a quella via?
Ma dai? Allora era via Giardini, e ci riunivamo a parlare di politica e ad organizzare iniziative. Le riunioni si tenevano anche nella sede del Circolo Stefano Paolino (un socialista che guidò le lotte operaie dei ceramisti nel primo dopoguerra e in seguito diventò deputato), in piazza Santa Maria Maggiore. Ricordo che proprio lì abbiamo organizzato una mostra sulla Resistenza, credo nel 1973.
Incominciamo dalla Resistenza.
Nel 1943 avevo 18 anni ed ero stata martellata dalle idee fasciste fin dalla nascita. Non ero riuscita a farmi un’idea politica precisa, ma la scelta contro i Tedeschi l’avevo fatta subito, così come quella contro i Fascisti quando si formò la Repubblica di Salò. Ho cercato le prime formazioni partigiane e mi sono messa a loro disposizione perché volevo fare qualcosa contro questi arroganti che ci avevano occupato. I miei fratelli tornati dalla Russia mi avevano raccontato le cose atroci fatte là dai Nazisti, e con il rogo di Boves avevamo capito che le stesse cose stavano capitando anche vicino a noi. Il rosso dell’incendio si poteva vedere anche da Piazza.
A novembre avevo ricevuto la nomina come insegnante elementare a Torrette, frazione di Casteldelfino, in Val Varaita. Là ho incontrato un gruppo di Ebrei fuggiti da Saluzzo e da Torino, che mi raccontarono degli arresti e del campo di concentramento a Borgo San Dalmazzo. Ero sconvolta.
In Val Varaita entrai i contatto con alcuni comandanti partigiani ed iniziai a fare la staffetta col nome di battaglia di Maestrina Rossana. In paese non ero ben vista, pensavano che fossi troppo libera, che avessi una condotta equivoca e che non fossi proprio un esempio per i bambini ai quali insegnavo. Alcuni genitori avevano informato il Provveditore. Non mi rendevo conto che mi stavo mettendo in un guaio più grande di me.
Ti hanno presa.
Sì, il 13 aprile 1944. Quattro militi della Guardia nazionale repubblicana hanno fatto irruzione a casa mia e buttato tutto all’aria; mi hanno portata via con le mani legate. A Sampeyre mi hanno interrogata e picchiata. Il giorno dopo mi hanno condotta nel carcere di Cuneo e poi in quello di Saluzzo. Il Provveditore, quando ha saputo che mi avevano arrestata, mi ha sospeso lo stipendio e sostituita con un’altra maestra.
A Saluzzo rimasi una decina di giorni, lì più di tanto non mi infastidirono perché avevano capito che non ero un pesce grosso. Poi mi portarono alle Nuove di Torino. Mi interrogarono di nuovo, la Polizia di Sicurezza tedesca questa volta, e non in carcere ma alla Pensione Nazionale. Mi condannarono a morte. Due mesi alle Nuove in condizioni pietose. Non sapevo che, in mano tedesche, non sarei stata fucilata: la Germania aveva bisogno di braccia per lavorare. Da Porta Nuova siamo partite in treno, eravamo in quattordici. Abbiamo cambiato treno a Berlino e dopo 80 chilometri siamo arrivate alla stazione di Fürstenberg. Di lì ci hanno fatte proseguire a piedi fino al campo di Ravensbrück.
Riesci a parlarne?
Dopo essere ritornata, per un po’ non ci sono riuscita. All’inizio tutti mi dicevano che ero stata fortunata a finire in Germania perché pensavano che non esistesse sofferenza maggiore di quella dei reduci della Russia e dell’Africa. L’angoscia di non essere creduta inquinava la gioia della libertà. Neppure gli uomini della Resistenza cercarono di capire i deportati, che non avevano meriti né gloria. Non avevano fatto la guerra: essere rinchiusi è da sempre simbolo di colpa.
Decisi di iscrivermi all’Università e di tentare il concorso magistrale. Ottenni delle supplenze in paesini della Langa, cercai di partecipare alla vita del paese, frequentando il caffè e il ballo, luoghi che non si addicevano ad una maestra. Come era successo a Torrette, la gente mi considerava frivola. Un’ispettrice scolastica indagò sulla mia moralità. Alcuni dei genitori degli alunni, però, apprezzavano il mio lavoro. Era comunque necessario per me scegliere sedi lontane da Mondovì, perché desideravo un’indipendenza dai miei genitori, il che contribuiva ad aumentare il giudizio negativo che la gente aveva di me.
Cominciai a raccontare la mia esperienza, in forma privata, quando iniziai ad incontrare persone che ne avevano avute di simili. Ma non ero sicura che ritrovarmi con altri deportati mi aiutasse a scacciare i fantasmi: io volevo raccontare a chi non sapeva o si rifiutava di sapere.
Che cosa ha fatto in modo che tu iniziassi a raccontare?
Fu l’uscita di un libro da Feltrinelli, Il flagello della Svastica di Lord Russel, nel 1955. C’era un capitolo dedicato ai campi di concentramento dove era nominato Ravensbrück, un luogo che non si trovava sulle carte geografiche e che nessuno sembrava avesse mai sentito nominare. Mio marito Giorgio (sì, mi ero sposata) lo trovò a Torino e me lo portò. C’era la storia del lager, dalla costruzione alla liberazione, nomi e cognomi dei responsabili degli stermini e degli esperimenti, disegni e fotografie. Ecco, in quel momento ripresi veramente a vivere e ruppi il silenzio.
Ma erano già stati pubblicati altri libri di memorie di ex-deportati, no?
Sì, parecchi subito dopo la fine della guerra, ma pochi con testimonianze femminili e tutte di ebree. Non una parola su Ravensbrück. La deportazione veniva infilata nel calderone delle esperienze di guerra. Sulla deportazione femminile, poi, si diceva ancora meno. Ma anche le voci maschili non erano molto ascoltate: la prima edizione di Se questo è un uomo di Primo Levi non ebbe nessun riscontro.
Cominciai a frequentare l’associazione degli ex-deportati di Torino, poi si formò un consiglio nazionale che organizzò il primo congresso, a Verona nel gennaio 1957. Dove ancora non si parlò di Ravensbrück e dove nessuna donna venne eletta negli organi dirigenti. Nel secondo congresso, a Torino nel novembre 1959, le cose cambiarono. Entrai a far parte del consiglio nazionale e promossi l’Amicale di Ravensbrück.
Quell’anno eri tornata a Ravensbrück.
Sì, a settembre, dopo quattordici anni. E dopo quattordici anni ho sentito di nuovo l’ossessione e il terrore. Ma intorno a me c’erano Tedeschi diversi, una folla che mi chiedeva scusa e mi offriva fiori.
Il congresso di Torino, comunque, segnò una svolta, anche nel mio modo di lavorare con i ragazzi; nel ’63 chiesi di prestare servizio alle Magistrali di Mondovì. Così negli anni della contestazione ho partecipato alle iniziative studentesche. Ero anche iscritta al PSI. Avevo iniziato il mio impegno politico e sociale, cosa che prima non riuscivo a fare, così presa a trovare un equilibrio esistenziale.
Come sei arrivata al tuo primo libro Le donne di Ravensbrück?
La voglia di raccontare c’è sempre stata. Dopo il congresso del ’59 cominciarono ad essere organizzate numerose iniziative sulla deportazione: mostre, viaggi ai campi di concentramento, documentari televisivi. Il femminismo mi ha aiutata anche a trovare credito per le mie idee.
La mia salute era pessima e fui collocata a riposo. Avevo provato molte volte a scrivere, ma non ero mai stata soddisfatta dei risultati. Quando ho avuto l’infarto mi sono resa conto che dovevo farlo. Fu allora che incontrai Anna Maria Bruzzone, anche lei monregalese, che mi propose di scrivere la mia storia. Iniziammo così il progetto de Le donne di Ravensbrück, che comprendeva, oltre alla mia testimonianza, le interviste ad altre deportate: Bianca Paganini Mori, Livia Borsi Rossi, Lina e Nella Baroncini. Uscì nel 1978 e fu il risultato di un’esperienza femminile e di una amicizia, la necessità di coniugare storia e memoria, l’unione di una dimensione femminile che attiene al privato con la capacità di generalizzare che non è così diffusa nelle donne.
Cos’hai fatto dopo?
Politica. Ho avuto incarichi nell’Amministrazione comunale monregalese e in quella dell’ospedale. Poi, convegni, interviste, iniziative. L’intervento che feci ad un convegno nazionale nel 1991 diventò il primo abbozzo del libro L’esile filo della memoria. Molti si stupirono perché era un testo letterario; era senz’altro un testo maturo.
L’esperienza della deportazione ti segna, sei diverso, reagisci in maniera diversa a quanto succede nel mondo, alla violenza sull’uomo. Non si è mai ex deportati.
È proprio il titolo che Bruno Maida ha scelto per il suo libro: una tua biografia con, in appendice, i tuoi inediti Taccuini dei Lager.
Così sono stati pubblicati… Durante l’internamento venni ricoverata per gravi problemi di salute; l’infermiera mi regalò carta e matita. Durante il lavoro forzato alla Siemens rubai della carta e ne feci un quadernino. Ci scrivevo pensieri, descrizioni e ricordi. Facevo disegni. Allenavo la memoria per non lasciarmi andare. Scrivere significava non pensare al dolore, alla fame, al freddo, ma anche affermare la propria umanità, rigettare la condizione bestiale del Lager. Ho dovuto anche distruggere quanto scrivevo per paura che venisse trovato: mi avrebbero punita. Ho salvato solo quanto avevo scritto negli ultimi tempi. Smisi il giorno della liberazione. Era il 3 maggio 1945 ed avevo da poco compiuto diciannove anni. Ero un fagotto di stracci, avevo con me le piaghe del corpo e due libricini di appunti.
Si tornava umani, e con l’umanità si ripresentavano le preoccupazioni per quanto poteva essere accaduto a casa, per quanto sarebbe successo a noi, il senso di colpa per essere sopravvissuti, il peso di un’eredità morale di milioni di vittime.
Lidia Beccaria in Rolfi, Mondovì 8.4.1925 – 17.1.1996
Bibliografia:
Lidia Beccaria Rolfi, Anna Maria Bruzzone, Le donne di Ravensbrück. Testimonianze di deportate politiche italiane, Einaudi 1978
Lidia Beccaria Rolfi, L’esile filo della memoria, Ravensbrück, 1945, Einaudi 1996
Alberto Cavaglion (a cura di), Il ritorno dai Lager, Franco Angeli 1993
Bruno Maida, Non si è mai ex deportati. Una biografia di Lidia Beccaria Rolfi, Utet 2008