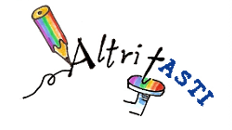di Alessandro Mortarino.
I primi giorni del nuovo anno si sono aperti con una triste notizia per la comunità astigiana, quella dell'improvvisa scomparsa del professor Emanuele Bruzzone, noto sociologo tra i promotori locali del Comitato per la difesa della Costituzione.
Laureato all’Università di Torino in Scienze Politiche con Filippo Barbano nel 1971, specializzato in Scienze dell’Educazione nel 1975, è stato dapprima docente di materie economiche e giuridiche nella scuola secondaria superiore, successivamente borsista ministeriale e contrattista presso la Facoltà di Scienze Politiche di Torino, dove ha tenuto corsi di Storia del pensiero sociologico, Politica sociale e Sociologia urbana, materia che ha insegnato nel Corso di laurea in Scienze Politiche. Ha fatto parte del Consiglio Scientifico della Sezione “Territorio” dell’A.I.S. e della Association de Recherche Cooperative Internationale di Parigi, diretta da P.H. Chombart de Lauwe.
Negli ultimi mesi aveva ripreso un'antica abitudine: quella di inviarmi puntualmente spunti, suggerimenti, articoli per animare il dibattito di Altritasti...
Alcuni di questi li avevamo pubblicati, in particolare due contributi per ricordare Carlo Sottile e per ragionare su Papa Francesco e sul generale argentino (astigiani di origine) Antonio Domingo Busso, altri li avevamo utilizzati come spunti per i nostri approfondimenti. Restava ancora una suggestione che Lele mi aveva fatto avere via mail il 12 dicembre accompagnandola con questo messaggio (testuale): Ciao Alessandro, ti giro una roba di anni fa che con una tua aggiustatina magari riducendo al max le domande può ancora essere utile adesso con questi qui che fanno tutto il possibile per lasciar sparire il territorio. Ciauu, Lele.
E' un'intervista fatta (crediamo) da un suo allievo in università: purtroppo siamo arrivati in ritardo e la pubblichiamo ora. Senza "aggiustatine" e con una grande voglia di abbracciarlo ancora...
-------------------------------------------------
Il prof. Emanuele Bruzzone insegna Sociologia dell’Ambiente e del Territorio presso la nostra Facoltà dove tiene anche il corso di Sociologia Urbana. Lo abbiamo intervistato per delineare gli aspetti di fondo di quella branca della sociologia che si occupa dei disastri e delle catastrofi, sia di quelli tecnologici che di origine naturale. È il modo che abbiamo scelto per parlare della tragedia che ha colpito il Sud-Est asiatico.
D: Buongiorno professore. Partiamo con il delineare a grandi linee che cosa si intende per sociologia delle catastrofi e come si articola.
R: La sociologia dei disastri o delle catastrofi, come parte della sociologia dell’ambiente, non ha una tradizione ancora molto consolidata negli studi e nelle ricerche applicate, in particolare nel nostro Paese. Se guardiamo alla sua comparsa nella letteratura sociologica internazionale, vediamo come nasca da principio, fin da fine anni Cinquanta nel contesto statunitense con ricerche finanziate da Enti prevalentemente di tipo governativo interessati soprattutto a valutare ex-post disastri e incidenti di tipo tecnologico più che naturale: molte committenze e relativi finanziamenti venivano dalla NASA, dallo stesso Pentagono e da Enti per l’energia per ricerche dove era importante acquisire conoscenze adeguate sugli effetti sociali connessi all’esistenza, accettabilità e legittimazione di impianti e infrastrutture produttive e/o militari legate all’energia nucleare.
Altro ambito di analisi è quello relativo alle catastrofi naturali, che certamente rientrano nel campo di indagine più recente della sociologia dei disastri, ma che presentano la dimensione caratteristica che taluni ricercatori americani identificano provocatoriamente o ingenuamente, direbbero acuti teologi e filosofi, con l’essere “ volute da Dio” e non prodotte dall’intervento umano.
D: In Italia, com’è la situazione?
R: La sociologia dei disastri, in questa accezione, è arrivata in Italia abbastanza tardi. Se l’inizio di una serie di ricerche che inaugurano la “via italiana” alla sociologia dell’ambiente può farsi risalire ai primi anni Settanta, da noi una sociologia delle catastrofi in quanto tale prende avvio nella seconda metà di quel decennio intorno ad un evento preciso ovvero il terremoto devastante del Friuli del 1976. Proprio da lì, da quello sconvolgimento socioterritoriale, si innesca – cosa che per esempio non era avvenuta, anni prima, intorno alla ben poco naturale catastrofe del crollo della diga di Longarone oggetto solo di benemerito giornalismo di inchiesta - una serie di studi dando espressione all’attività di ricerca di un gruppo di sociologi allievi di Franco Demarchi gravitanti intorno all’Istituto di Studi Internazionali di Gorizia (ISIG) e successivamente all’Università di Trieste. Per quanto riguarda poi un più allargato ambito di riflessione su questa tematica interno alle scienze sociali interdisciplinariamente intese, occorrerebbe aprire una considerazione specifica sul caso italiano,a partire dalla sua storia, e per così dire autoconsapevolezza territoriale. Non abbiamo per esempio quasi per nulla, nonostante le serie storiche delle scienze della terra mostrino una impressionante sequenza di fragilità, una qualche memoria collettiva consolidata di come si reagisca ad una catastrofe naturale, se non per alcuni eventi disastrosi degli ultimi decenni. Eppure la memoria delle comunità investite è anch’essa un cruciale fattore di “protezione civile”, di rivendicazione di maggiore messa in sicurezza con la prevenzione dei disastri dei singoli territori…
D: Il terremoto del Friuli costituisce un esempio di catastrofe naturale, ma abbiamo prima accennato anche agli studi relativi a disastri tecnologici, provocati più o meno direttamente dalle attività produttive ad elevato impatto ambientale gestite irresponsabilmente: ci sono, ci sono stati in Italia esempi in tal senso?
R: Quello che subito viene in mente è l’incidente di Seveso, in Lombardia, dove l’impianto chimico dell’ICMESA provocò un’enorme dispersione a vasto raggio nell’ambiente circostante di diossina. Drammatico evento di dimensioni e impatto così rilevante da diventare, oltre che un punto di svolta per la riflessione e la pratica ambientalista, anche l’inizio di serie politiche istituzionali e pubbliche di mappatura degli impianti pericolosi e di prevenzione degli incidenti tecnologici in Italia come in Europa. Non a caso ancora oggi, dopo decenni, una delle direttive di politica ambientale della Unione Europea, periodicamente aggiornata, porta ancora la denominazione “Direttiva Seveso”. Mentre in Italia, purtroppo, si è molto attenuata la prospettiva di prevenzione e di accorta regolazione innescata da quell’emblematico evento.
Questo mi permette di sottolineare un aspetto che ritengo importante. La sociologia dei disastri, in Italia, ha provato anch’essa, pur in una realtà non esattamente propensa a deliberare e intervenire sulla base di conoscenze adeguate, a seguire un percorso simile esperito in altre società. Caratterizzandosi cioè con un forte orientamento alla policy: ovvero studiare non solo per vedere ex post cosa sia successo, ma per trovare i punti di inserzione, in termini di acquisizione di dati, velocità di informazioni, comunicazione alle popolazioni e così via per poter successivamente disporre di adeguate politiche di prevenzione, ad iniziare da una migliore circolazione della risorsa-chiave, l’informazione.
D. In quest’ultima direzione esistono esempi positivi da seguire?
R: Tutti ad esempio riconoscono al Giappone non solo una capacità tecnologica e scientifica di monitoraggio capillare del territorio, cui naturalmente conseguente anche una migliore informazione immediata a ridosso dell’evento, ma anche la presenza di un tipo di organizzazione sociale modellata essa stessa sulla capacità di reagire, attenuandone al massimo le conseguenze negative, ad un evento catastrofico. Mi riferisco per esempio alla tipologia delle costruzioni e dell’infrastrutturazione urbana progettate e realizzate per resistere a stress geologici di ampia portata, alle dinamiche di allarme e emergenza simulate periodicamente in ogni tipo di ambito, dalla scuola materna fino all’università, in grandi contenitori di popolazione come la metropolitana o in una mega-fabbrica. Dunque un’intera rimodulazione dell’habitat ruotante intorno alla probabilità di un evento catastrofico di tipo naturale, come il terremoto. In Giappone, sismi che valgono in magnitudo quattro o cinque volte il terremoto del Friuli, producono pochissime vittime spesso peraltro non direttamente imputabili al terremoto stesso: più morti per infarto che da cedimenti strutturali di edifici!!!
Si provi a paragonare questo tipo e grado di organizzazione e attenzione ad eventi catastrofici alla situazione italiana alle pendici del Vesuvio con un tipo di edificazione e urbanizzazione concentratissima quanto sregolata: sono sicuro che Massimo Troisi che pur da vivo prendeva in giro i giapponesi in quanto turisti, tenti da mo’ di convincere, poco ascoltato genius loci,i propri concittadini vesuviani, pur con i debiti scongiuri, a prenderli ad esempio come pianificatori e realizzatori. I geologi lo ascoltano e fanno il loro mestiere bene come i loro colleghi. Altri?!?
D: Di fronte all’evento oggetto di studio, su quali aspetti si concentra la sociologia delle catastrofi?
R: Intanto certamente indaga i comportamenti individuali così come quelli collettivi per così dire “a caldo”; inoltre e successivamente valuta l’impatto dell’evento sulla comunità ovvero dopo la prima esperienza traumatica iniziale lo osserva nelle fasi successive: dopo l’emergenza e le prime risposte in termini di soddisfacimento dei basic needs (fame, sete, cura dei sopravvissuti feriti, mancanza di riparo e di vestiti ecc., ma anche di un minimo di relazioni per non sentirsi persi …) delle popolazioni colpite, la fase di come ci si risitua e ci riorganizza, autonomamente o con supporti e aiuti esterni, fattore quest’ultimo che diventerà nel bene e nel male passando alla fase della”riabilitazione”, della ricostruzione in loco o altrove. Naturalmente via via occorre sempre di più tenere in considerazione le variabili socio-culturali, i caratteri originari delle popolazioni coinvolte . Naturalmente qui si affacciano nodi e problematiche che “sconfinano” in altri ambiti: ad esempio radici religiose e dimensioni filosofiche: diventa importante considerare gli atteggiamenti culturali dove tutto ciò si sedimenta. Ad esempio si può richiamare la dimensione non così semplice come appare del fatalismo, proprio di molte culture, che può non eludere il verificarsi di una sorta di effervescenza sociale e fusionale della comunità che fa corpo per provare a reagire, riprende a darsi da fare per i vivi e per i morti.
E qui occorre riferirsi anche all’appena accennata componente degli aiuti provenienti dall’esterno, ad esempio suddivisibili in volontariato d’urgenza, volontariato che permane sul territorio e quello che progetta poi da lontano le relative dinamiche di ricostruzione attivando un ciclo che può rivelarsi virtuoso o corrotto dove, finito il buon cuore, si protagonizzano gli interessi.
D: Come legge l’evento dello tsunami asiatico e le sue conseguenze?
R: Ci sono variabili molto complicate, che vanno dalla presenza dei turisti occidentali fino agli impatti futuri di tipo geopolitico. In questo caso non siamo in presenza genericamente di interventi di soccorso portati da un generico volontariato internazionale della società civile, ma abbiamo il ruolo di organizzazioni come l’ONU e le sue Agenzie di coalizioni di Stati che hanno interessi umanitari e non solo in quell’area: da sociologi comprendiamo come il ragionamento in questo senso debba farsi molto più vasto come pure enorme è il materiale, le fonti di informazione su cui riflettere per noi che siamo lontani dal “terreno”, ma stiamo in una Torino ricca di solidarietà, di esperienze di ONG, di conoscenze sociologiche e geo-politologiche.
Nel caso specifico del Sud-est asiatico, balza subito agli occhi uno dei temi che da sempre è presente negli studi di sociologia delle catastrofi, ovvero la maggiore o minore vulnerabilità sociale dell’area colpita, in rapporto anche alla sua vastità. Si è palesata una vulnerabilità del sistema di comunicazione di base che deve far riflettere. Non aver innescato una connessione con un qualunque mezzo informativo in un arco di tempo di un paio d’ore, che potrebbe sembrare troppo breve, per trasmettere informazioni necessarie all’evacuazione delle popolazioni, non ha consentito gli interventi che invece avrebbero potuto avere luogo e incidere notevolmente non tanto sulla diminuzione del danno quanto in termini di minor perdita di vite umane. Questa è una prima variabile strutturale che è intervenuta in questo caso. E anche qui più e più volte nella stampa internazionale è tornato il confronto col Giappone efficiente.
D: A suo giudizio, quali saranno gli impatti dello tsumani sulle comunità locali?
R: Non lo so: osservo però che le scienze della terra, che si catalogano tra quelle cosiddette “dure” e relativamente esatte hanno coniato il termine “magnitudo” per quantificare l’ampiezza e la forza devastante di un fenomeno come questo terremoto più maremoto. Però esiste anche una magnitudo di tipo sociale: da un lato essa riguarda il dato oggettivo del numero di morti, dall’altro rimanda secondo me anche al dato mediatico della persistenza in prima pagina dell’evento. Dovuta, come sappiamo, anche, ma qualcuno dice in prevalenza, alla presenza notevole di vittime non locali, i turisti occidentali. Il turismo ha avuto diverse conseguenze per quelle aree: certamente l’arricchimento di chi lo gestisce e ci lavora grazie all’arrivo di stranieri da tutto il mondo, ma anche conseguenze non direttamente visibili. Pensiamo ad esempio all’impatto su popolazioni locali originariamente e tradizionalmente non insediate sulle coste ma che, per effetto del turismo, vi si sono trasferite in cerca di lavoro. Ci sono alcune zone delle aree turistiche investite dallo tsunami che prima non conoscevano nè turismo, né contatto uomo-mare. Come esistono aree con pescatori da sempre e luoghi con gente che è andata su quel mare e a fare la guida sub arrivando da altre zone. Comunque gravitando su un costruito costiero “innaturale” dimensionato non sul modulo del villaggio tradizionale, ma per contenere alcune migliaia di turisti per turno. Non dico che sia come costruire centinaia di condomini alle falde del Vesuvio, ma tant’è…...
D: Nelle zone colpite stanno affluendo molti aiuti e grandi quantità di denaro: come gestirle?
R: Probabilmente una delle cose da studiare non sarà tanto l’ovvia mancanza di una struttura di monitoraggio specifica per questi tipi di eventi naturali devastanti, ma andare a vedere che cosa è successo in realtà nella catena di informazioni esistente. Si dovranno impiegare anche per questo i miliardi di dollari che arrivano, ma come verranno spesi? Si andrà verso acquisto e dotazione pesante di sistemi di monitoraggio e prevenzione simili a quelli del Giappone o dell’Australia oppure governi e tecnici dovranno trovare il modo per avere una catena di informazione velocizzata e collegata senza intoppi con chi altrove o dal satellite sta monitorando il tutto? Esiste il rischio che si rifilino a questi Paesi costose tecnologie magari un po’ obsolete invece di verificare come mai telefoni normali o cellulari o satellitari non hanno funzionato. Nell’inceppare la catena dell’informazione d’allarme maremoto non è escluso siano intervenuti anche fattori di tipo “politico”: nelle aree interessate esistono esempi di governi non esattamente trasparenti e democratici alle prese anche con conflitti armati interni e popolazioni di serie A e B: quale la convenienza personale e di regime a comunicare o non comunicare certe notizie? La stessa contabilità, minimizzazione o enfatizzazione, del numero delle vittime può essere utilizzata per attrarre o respingere, ad esempio, aiuti internazionali desiderati o meno che comunque implicano una visibilità internazionale, qualcuno che verifichi per esempio il grado di rispetto dei diritti umani. E’ evidente dunque che un evento del genere va ben al di là del campo di analisi della sola sociologia dei disastri coinvolgendo problematiche di amplissima portata, a cominciare da quelle geopolitiche: il mix è impressionante. Tutte le dimensioni della globalizzazione vi si ritrovano: ambiente, pace e influenza e interessi geopolitica, informazione in tempo reale e suoi accessi, restrizioni, strozzature. Un “caso di scuola” si potrebbe dire per ricalibrare molte analisi: non troppo distante,”mutatis mutrandis” dal turnig point dell’11 settembre 2001.
D: Si è parlato molto della possibilità di riattivare quanto prima il mercato del turismo internazionale nelle aree colpite…
R: Il ricostruirsi della comunità non sarà ovviamente facile. La parola d’ordine “riattivare quanto prima il turismo”, significa comunque anche confermare, nel bene ma anche nel male, un modello di sviluppo di un certo tipo. D’accordo che le casse di quei Paesi ricevono dal turismo uno dei loro maggiori introiti, ma non sarebbe male interrogarsi più a fondo su questo aspetto.
Si diceva dell’importanza di ristabilire velocemente condizioni di vita accettabili, rispondendo ai bisogni fondamentali. Il problema è anche che, tra le aree colpite, molte avevano questa scopertura di bisogni da molto tempo prima dello tsunami. Le popolazioni colpite hanno dimostrato una solidarietà incredibile, a conferma di una tradizione di ospitalità vera, non mercantilmente simulata: in molti casi si è verificata una incredibile disponibilità degli “autoctoni” a fornire immediato aiuto, a “dare un ramo a cui aggrapparsi “al turista in difficoltà…Atteggiamento riconosciuto da tutti i sopravvissuti occidentali. Cosa hanno ottenuto intanto in cambio? Purtroppo anche un comportamento ben diverso: un investimento massiccio di risorse da parte, per esempio dell’Italia, non tanto per recuperare, ma per riconoscere selettivamente i “propri” morti evidentemente di serie A. Per me è veramente scandaloso, ben più che tornare pochi giorni dopo a sguazzare a fianco delle rovine. Quante risorse è costato, sta costando: ogni settimana retribuita degli specialisti medico-legali passata a riconoscere il DNA di un turista occidentale a quanti sacchi di riso e kit per depurare l’acqua per i bambini sopravvissuti equivale?? Impressionante “nazionalizzazione” della morte per di più mediatizzata incessantemente. Una morte non vale come un’altra? Contraddicendo così principi antichissimi: ognuno uguale di fronte alla morte, ricco o povero, occidentale o non, nativo o non nativo. Rimpatriati tutti i cadaveri occidentali, quale sarà il grado di attenzione dei media sulla catastrofe e le successive fasi di ricostruzione?
Un’ultima considerazione. Eventi non definiti catastrofi naturali continuano a colpire con una certa intensità vittime innocenti: la fame strutturale, “banali” per noi malattie o l’AIDS producono sistematiche quotidiane catastrofi che ci si rifiuta di chiamare così.
Allora, chi è fatalista: l’Occidente dai civilissimi valori che accetta senza intervenire queste cose o la madre a braccia aperte, disperata davanti al mare nemico, che attende invano la restituzione dei figli, domandandosi in che cosa si reincarnerà il suo più piccolo scomparso?
Bibliografia minima:
AA.VV., Rischio, gestione del rischio, comunicazione del rischio, in Notiziario I.S.I.G. (Istituto di Sociolgogia Internazionale di Gorizia), quaderno monografico, III, n. 4/dicembre 1994 pp. 20.
B. De Marchi, L. Pellizzoni, D. Ungaro, Il rischio ambientale, Bologna, Il Mulino, 2001.
E. L. Quarantelli, Disastri, voce della Enciclopedia Italiana delle Scienze Sociali, vol. 3, pp. 140-150, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1993.
G. Bettin, Petrolkimiko. Le voci e le storie di un crimine di pace, Milano, Baldini e Castoldi, 1998.