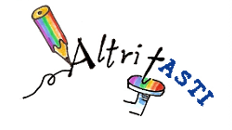Mercoledì 5 giugno alle ore 21:00 all'Archivio Storico di Asti (Palazzo Mazzola) verrà presentato l'ultimo romanzo di Gianfranco Miroglio "La culla e i giorni".
Può capitare di nascere in modo per lo meno improbabile, con la conseguenza immediata di dover affrontare, fin da piccolo piccolo, momenti e passaggi difficili o strambi.
Come imbattersi nella voce di un fratello-gemello bellissimo ma mai comparso davvero alla luce del sole. Di doverne subire il richiamo e il fascino, la voce e il rimpianto. Un po’di rimorso. O farsi accompagnare da lui a raccogliere storie attraverso giorni e stagioni, attraverso colli e pianure, cercando gli orizzonti e la luna, desiderando i colori del mare. Aspettando la neve...
Questa la postfazione del libro:
Una movida risonante, di Elio Grasso.
Così dice Matisse: “dovunque voi siate e sarete, anche qui, in un buco così, troverete una luce, ogni tanto, che ricorda il Marocco e l’Oriente. E gli arabeschi che, prestando attenzione, troverete appoggiati sul mondo, non sono il superfluo, non sono un capriccio di Dio, sono l’unico modo per invitare e concentrare lo sguardo. Sono l’essenza, il cuore che appare. Ogni tanto. Au revoir”.
Monferrato, Langa… forse sono incroci di venti, di vigne, o di passi giunti da paesi diversi, o forse sono soltanto incroci di mitologie, leggende, desideri di noi genovesi che stiamo laggiù in fondo, dove c’è il mare. Mentre lì è quasi Francia. E poi riconosciamo ai piemontesi di quelle parti e di quella genìa, noi meridionali del nord, ovvero liguri, una serie d’invenzioni terragne, simmetriche, quasi “alpine” e quasi marine, fermo restando quell’impronunciabile fermento ecologico e hard costituito dalle distese di vigne. Luogo strumentale del genio, dello happy hour brumoso e blindato: provate ad aggirarvi tra i filari, sentirete immediatamente lo scatto della carabina. A torto o a ragione il regio popolo ha un dna enologico e cacciatore, quasi una solenne purezza che avvertiamo subito in questa Ballata inventata, prodotta e scritta da Gianfranco Miroglio con ostinata veemenza e spolverata, quasi senza ritegno, lungo i confini misteriosi (almeno per chi non è di quelle parti) e mobili fra Roero, Monferrato meridionale e Langa. Gli incastri definiscono prima di tutto la favolosa geografia, mentre lì in giro non mancano di farsi osservare i personaggi di una movida terricola e risonante, folta e di forte muscolatura: le scale risuonano di passi pesanti, i corpi risentono del calore biancastro ai piedi dei pendii, le voci sono sempre alte e pronte all’esagerazione del punto esclamativo al termine di ogni frase. E, in gran parte delle scene d’interni, sono più le domande che le asserzioni.
Ma quando Miroglio fa partire i suoi eroi, femmine d’onorata casata e ometti dubbiosi, si scatenano controversie e amabili spintoni, pensieri gerarchici e faldoni di tenerezze, mentre la ricerca di buoni servigi non viene mai meno. Su tutto si allargano i suoni del terreno, delle attività campagnole, delle numerosissime campane. Appaiono i nomi delle genti, qualcuno inizia a raccontare, a dire la sua, e inizia la cavalcata in piena luce di personaggi che sembrano, a un tempo, figli e fratelli e sorelle dell’autore. Non perché si confondano figure egemoniche e meno conformi, o si permetta loro di incrociarsi in stanze e letti comunitari mentre il paesaggio dice la sua con fango, neve, vento o bruma e calura. Miroglio governa il tempo con effetti benefici, i capitoli sono caratterizzati da date precise, non ci sono dubbi sulla storia rievocata e sulla cronaca facoltosa a cui si tentano allacci effusivi, e scoperchiamenti emotivi.
I nomi di questo libro possiedono una precisione anagrafica di prim’ordine, più che naturale avendo l’autore cromosomi autoctoni. L’ingegnosità langarola (o monferrina, chi lo sa) viene da lontano, da stirpi il cui tempo iniziò millenni fa e con nessuna intenzione attuale d’estinguersi. Nel bel mezzo di creste geografiche e temporali chi abbiamo? Facile ricordarlo, più difficile notificarlo, pena conformismi quasi reazionari o contestazioni di bassa lega. Ma Fenoglio e Pavese non sono chimere facili. E stanno più in solitaria di quanto si creda. L’epica è finita da un pezzo, l’autore lo sa, e ancor più chi scrive questa noterella, con tutte le differenze generazionali mondane e private. In mezzo, non dimentichiamolo, ci stanno la guerra e il dopoguerra. Ci sta la morte per tumore e per colpo di pistola.
Avete mai sentito il sordo rumore, derivato da eventi siffatti, che aleggia da quelle parti? Chiedetelo a poeti e poetesse nativi o adottati (una in particolare, residente qualche collina più in là) cosa significhi. Chiederlo a Miroglio non serve, lui sta qua, dentro al libro, dentro alla comunità d’animi le cui gesta narra con abbondanti riflessioni e irriverenti (talvolta) evocazioni. Cavalieri antichi si aggirano ancora su queste terre, e affiorano nascite a dir poco fantasiose tra filari e casali, come quella descritta in alcuni capitoli di La culla e i giorni. Di che si tratta? Di un Coso qualunque o di una presenza fisica alquanto dubbiosa di sé e soprattutto dei fool on the hill lì attorno? Ma Coso non sa che sono tutti eroi ed eroine insigni, nemici degli agriturismi, capaci di urlare, addentare e imbarcarsi in viaggi estenuanti e intimi innamoramenti per corpi piccanti e provocatorie e tonde carnalità. I faccia a faccia non mancano in queste pagine, né il cibo delle vigne e altre famosissime vettovaglie di cui si percepiscono odori sapori e turgori. Discussioni accanite si alternano a pranzi e cene, a improvvise partenze e inopinati ritorni, non serve qui descriverli ma semmai saggiarne le provocanti posizioni in boschi e vigne eterni, in cammini storici per ognuno dei protagonisti e delle famiglie coinvolte.
La familiarità spesso eccede, almeno quanto per alcuni s’esaltano bellezze corporee in mezzo alla natura d’esuberanza trattenuta. Certo, in stanze dove l’assedio delle cose si fa sentire, con quel tanto di “opulenza banale” a cui spesso la provincia è dedita, diventa facile occuparsi d’altro, farsi gestire qualche eccitazione troppo a lungo lasciata da parte. È pur sempre un prestigio personale, una valutazione dell’eleganza primaria di alcuni, qualcosa da non tenere occulto per lo scrittore Miroglio. La memorialistica si occupa di impedire l’estinzione, scrivere e riscrivere ostacola l’erosione, almeno finché si è vivi occupare il proprio suolo è l’unica componente umana da difendere a forza. Dunque in questa Contea scritta la forza si avverte, i personaggi l’avvertono, sembrano cercare una via verso l’esterno in modo che il lettore si ritrovi sullo stesso terreno di eventi e situazioni, di scambi dialoganti, paturnie, risate, equivoci, risvolti inattesi: tutto alquanto complesso e aggrovigliato, così come talvolta sono aggrovigliati i tralci delle viti.
Il ripetuto Chiostro di Miroglio non è certo àmbito di clausura, se mai ha le fattezze di un ampio territorio di confini precisi, dove gli attori possono spostarsi con incedere antichissimo, abbandonando le madeleines per più vive e ricche scorte alimentari e carnali, ancestralmente recepite come radici pagane, tra clivi colli fiumi e borghi. E se il racconto fosse un teatro, o meglio un film condotto su evocazioni vagamente proustiane, con tocchi di Scola, Wenders e fratelli Taviani presi in prestito dal Museo del Cinema torinese? Non perché dobbiate saltare sulle vostre poltrone, ma ricordiamo che queste zone hanno dato i natali a un certo Paolo Conte, da un pezzo intenditore di turbinii filmici. Asti può ben dirsi calamita (perfino un po’ bieca) regionale, con tutto il circondario fin troppo partecipe delle cronache mondane. La terra su cui viaggia l’autore è meravigliosamente periferica, al contrario, e l’aria che vi circola ha equilibri e squilibri diversi per un genovese.
Siate indulgenti, e questi pensieri sollevino Miroglio da responsabilità proprie, in fondo langaroli e liguri sono men che cugini. E le parentele, si sa, anche alla lontana sono spesso disagevoli. Ma la differenza tra borgo e città viene evocata pressoché a ogni pagina, le pietre e le terre locali sono predominanti rispetto alle sgrassate mura cittadine, e non perché il romanzo sia ecocompatibile, se mai perché in campagna le padelle si ripuliscono meglio che in città, per quanto si voglia “provinciale”. Siamo al dunque, alle frasi e ai balbettii della famiglia, a viaggetti di buon senso nella Balilla ancestrale alla ricerca di girandole luminose, lingue ancor più madri, chiarimenti toponomastici e genealogie, astuzie e garbi, fantasmi e revival politici: in una parola, tutti maliziosi tepori. La festa è un’apparizione per molti, la morte di qualcuno viene accettata con preventivo languore e infine scenografica autorità emotiva. E poi più in là ci sta il mare, è pur sempre un confine più preciso per le genti di Langa e monferrine, bisogna abituare i ragazzi a considerarlo, a tenerlo come ultimo domicilio (e se non domicilio, almeno provvisorio campeggio) prima che le Alte Cariche mandino tutto in vacca.
Negli ultimi capitoli si avverte non tanto l’icona di un turismo del sentimento quanto l’allontanarsi da dopoguerra sventurati, con provvidenziali storiografie familiari di prim’ordine, di dialoghi fatti in piedi e riprese dei viventi: all’insegna di panorami e oggetti integri, i cui spiriti siano bene in vista delle anime dei viventi. Non memorabilia, ma l’inconsueto racconto di un uomo che ancora ricorda gli uomini e le donne i cui spostamenti hanno creato un mondo, un casato portatore di ricchezza pressoché leggendaria in Casa Matisse. Leggere per credere, arrivare al dunque della narrazione, per comprendere cosa sia Casa Matisse, come possa trattenerci nella propria atmosfera. Nella fisiognomica edilizia, paesaggistica, intellettiva, compare l’unità formale di un romanzo dai molti centri, dal montaggio lirico e veristico. Il set mette al passo la realtà di anni che sono stati, e robustamente ancora sono. Ma più di tutto si vedono traversare i ponti e le rive dell’acqua la folla dei personaggi, non soltanto nella congiuntura mnemonica di un indaffarato abitante d’incroci collinari dove ognuno sta, da allora a oggi.