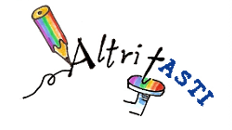di Pasquale Pugliese.
Note a margine dell’azione degli attivisti di Ultima generazione all’ingresso di Palazzo Madama.
Prima premessa: la dichiarazione di Ultima generazione, l’organizzazione che ha pittato l’ingresso di Palazzo Madama il 2 gennaio scorso è del tutto condivisibile tanto nelle motivazioni del gesto e quanto nella scelta di fondo della “disobbedienza civile nonviolenta”, dentro alla quale s’inquadra l’azione specifica: “Alla base del gesto, la disperazione che deriva dal susseguirsi di statistiche e dati sempre più allarmanti sul collasso eco-climatico, ormai già iniziato, e il disinteresse del mondo politico di fronte a quello che si prospetta come il più grande genocidio della storia dell’umanità”...
Sulla loro pagina web il comunicato continua con la dichiarazione di un’attivista: “Ho scelto e continuerò a scegliere di compiere azioni di disobbedienza civile nonviolenta perché sono disperata. Ovunque guardi vedo dissociazione, negazione, alienazione rispetto alla crisi climatica. (…) Non possiamo illuderci che fare la raccolta differenziata e partecipare a cortei organizzati sia sufficiente. È, di conseguenza, proprio al governo e alle istituzioni che rivolgiamo la nostra rabbia di protesta…”.
Seconda premessa: la “disobbedienza civile nonviolenta” alla quale fa esplicitamente riferimento il movimento ha una lunga e importante storia nelle democrazie occidentali di avanzamento dei diritti e dei metodi di lotta. Basti pensare, per esempio, alla teoria ed alla pratica di Henry David Thoureau, Hannah Arendt, Martin Luther King, Gene Sharp, Judith Butler in area statunitense; a Danilo Dolci, Aldo Capitini, Pietro Pinna, Marco Pannella, per citare i più noti, in area italiana. “La disobbedienza civile insorge” – scrive Hannah Arendt nel saggio La disobbedienza civile, con parole tanto chiare quanto definitive – “quando un numero significativo di cittadini si convince che i canali consueti del cambiamento non funzionano più, che non viene dato ascolto né seguito alle loro rimostranze” oppure che il governo sia “ormai avviato verso una condotta dubbia in termini di costituzionalità e legalità. (…) In altre parole la disobbedienza civile può essere posta a servizio di un cambiamento auspicabile e necessario o di un altrettanto auspicabile mantenimento e ripristino dello status quo. (…) In nessuno dei due casi la disobbedienza civile può essere equiparata alla disobbedienza criminale”.
Date queste premesse, dal mio punto di vista, non è in discussione se siano giuste le motivazioni delle loro azioni né se sia opportuna la scelta esplicita della disobbedienza civile come forma di lotta, che esclude l’uso della violenza, ma se le specifiche azioni realizzate, le tecniche adottate, siano funzionali o meno allo scopo da raggiungere. Il principio fondamentale della lotta nonviolenta – e quindi anche della disobbedienza civile che ne è una delle principali forme di azione collettiva – è la coerenza dei mezzi utilizzati con il fine da raggiungere (“il mezzo sta al fine come il seme sta all’albero” era la formula ripetuta da Gandhi). Una delle dinamiche strategiche è quella di essere comunicativa, ossia svolgere delle azioni capaci di suscitare simpatia nelle cosiddette “terze parti”, in coloro che assistono indifferenti, in specie attraverso i media, invece di coinvolgersi nella lotta in corso: la simpatia (= disposizione d’animo favorevole, sentimento istintivo di attrazione; affinità, sintonia) dell’opinione pubblica, affinché solidarizzi con il gruppo che conduce la lotta e contribuisca, con lo schierarsi dalla loro parte, al successo del movimento di protesta e proposta.
Ecco, temo che la troppa distanza tra i mezzi usati (prima della vernice lavabile sulla porta del Senato, la stessa sorte era stata riservata alle teche di famosi quadri di alcuni musei) e il fine da raggiungere – l’interesse e l’azione della politica e dell’opinione pubblica sulla crisi climatica (che è parte di una più ampia crisi sistemica globale) – e la specificità delle azioni, che attirano antipatia anziché simpatia, perché al limite dell’atto vandalico su beni pubblici (le opere d’arte, il Senato della Repubblica), siano contro-produttivi rispetto agli obbiettivi da realizzare. Credo che questo tipo di azioni – che portano l’attenzione di tutti sulle mani che imbrattano anziché sull’allarme che lanciano – danneggino l’obiettivo di sensibilizzare gli indifferenti e la politica sull’emergenza climatica, anziché supportarlo e fare pressione. Anzi forniscano al potere un alibi per indicare negli attivisti i nemici, anziché i difensori, del bene comune, criminalizzandoli. Come sta puntualmente avvenendo.
Non mi pare un caso che l’organizzazione britannica Extinction Rebellion – che fin dal 2018 aveva dato il via ad azioni di disobbedienza civile di massa, con occupazione dell’area intorno al parlamento di Londra, poi sviluppatesi in altri Paesi – proprio lo scorso 31 dicembre ha comunicato l’allontanamento dalle azioni di occupazione e interruzione dei pubblici servizi, come tattica primaria della disobbedienza civile che non ha dato i risultati sperati e ha visto, anzi, la criminalizzazione delle proteste, per procedere alla costruzione di ponti di comunicazione con tutti i cittadini, collegandosi agli altri movimenti che si battono per la giustizia sociale (e suggerirei anche per la pace, vista la stretta connessione di temi). Mi pare un segno di lungimiranza. Del resto, “la nonviolenza è affidata ad un metodo che è aperto e sperimentale” scriveva Aldo Capitini ne Le tecniche della nonviolenza: si tratta di sperimentare ancora, imparando dagli errori, come accade in ogni serio e necessario esperimento. Oggi più che mai.