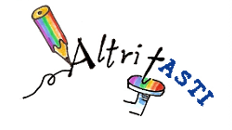Intervista a Judith Malina di Rossella Battisti.
Intervista a Judith Malina di Rossella Battisti.
Il teatro del Living da oltre 60 anni è in prima linea per difendere i diritti umani. Ce ne parla l’artista 85enne che lo fondò nel 1947 con Julian Beck. Un percorso in linea retta di azioni sociali e splendide utopie per il mondo.
La libertà è partecipazione, cantava Giorgio Gaber e, da molto prima di lui, Judith Malina dice che allo «spettatore» preferisce il «partecipante» ...
Lo ripete alla platea di giovani e giovanissimi, accorsi al Petrella di Longiano per ascoltare l’inedito duettare che questa veterana del teatro d’assalto fa con una «nipotina» elettiva, Silvia Calderoni dei Motus. E ci tiene a precisarlo anche prima, dietro le quinte, dove l’abbiamo incontrata. Un’onda di capelli neri, due occhi come diamanti scuri che scintillano di un’energia indomabile e un sorriso enigmatico da guru d’Occidente.
Quarant’anni di Living Theatre assieme a Julian Beck, più di venticinque dopo la sua morte affiancata da Hanon Reznikov e ora da collaboratori come Tom Walker e Brad Burgess: signora Malina sono percorsi che si differenziano in qualche modo?
«No. È una linea retta che corre. Siamo andati avanti col lavoro di Julian. La storia cambia, ogni momento è un cambiamento. Noi del Living vogliamo essere nel flusso di questo cambiamento. C’eravamo nel ‘68 e abbiamo fatto parte di quel movimento. Ci siamo adesso ed è un modo di essere diverso e nuovo».
Uno dei vostri punti fermi è che il teatro deve poter cambiare il mondo. Se guardiamo come è diventata la società contemporanea, non trova che sia stato il mondo piuttosto ad aver cambiato il teatro e le sue regole?
«In un certo senso è vero. Ma questo non vuol dire che si debba smettere di opporsi alla guerra, allo sfruttamento e all’ingiustizia. Io credo che il Sessantotto sia stato un successo e oggi abbiamo giovani pronti a fare altri cambiamenti».
Segnali ce ne sono, il Valle occupato dagli artisti a Roma, per esempio. Ma dove cercare un teatro «vivo» oggi? Lei ha vissuto in un’epoca dove essere pionieri era relativamente semplice. Adesso che tutto è stato provato, quali contenuti, quali forme si possono inventare?
«Non è vero che era più facile sperimentare: venivamo arrestati anche se semplicemente ci spogliavamo. La società era più rigida. Inoltre, c’è ancora molto da fare a teatro. E questo è il miglior periodo per la ricerca: ci sono tecnologie più avanzate, una generazione più radicale…»
Come i Motus, intende? Come vi siete incontrati e «riconosciuti»?
«Quando abbiamo visto la loro produzione di Antigone a New York che aveva dei riferimenti alla nostra, ci siamo incuriositi notando una visione simile seppure diversa. Ne abbiamo parlato e ci siamo incamminati insieme in questo progetto».
Quali i punti in comune, quali le differenze?
«Una visione ottimista, una prospettiva sul futuro e la speranza di poter cambiare. Siamo due compagnie e, sulla scena, due persone di generazioni lontane fra loro che discutono di come è stata e come è adesso lasocietà. Questa è la sola realtà che conta: io e lei e i partecipanti sulla scena. Lei che scrive e io che sto parlando. Il passato è un pacco di bugie storiche, il futuro è solo una visione. Si vive adesso».
Una visione molto zen. Mi fa un esempio concreto di come ciò possa influire sulle regole di mercato?
«Julian Beck poteva continuare a dipingere e diventare come Cy Twombly. Ma ha smesso per dedicarsi al teatro e ad azioni sociali. Noi qui in scena chiamiamo tutti a lasciare un segno, lo facciamo insieme e nessuno lo può vendere per milioni di euro. Ecco come si schiva il mercato. Siamo poveri, ma liberi come le murene che scivolano tra uno scoglio e l’altro».
Il Living ha vissuto una lunga parentesi italiana – una per tutte: la lunga residenza a Rocchetta Ligure tra il 1999 e il 2004 -, perché ha scelto di tornare a New York?
«Siamo stati costretti ad andare via da New York dopo The Brig, uno spettacolo che criticava duramente la guerra in Vietnam. Una sorta di lunga tournée … Ma ora NewYork ha bisogno di noi».
Se è per questo, l’Italia non è messa benissimo. Almeno voi avete Obama…
«È un bene che gli americani lo abbiano votato e non solo per un superamento del pregiudizio razziale, ma anche per lo spirito che dimostra nei suoi pensieri. Personalmente, io non voto: sono anarchica. Votare e prendere atto di quei voti è come ritenere che ci sia una maggioranza più intelligente della minoranza che si deve sottomettere alle sue decisioni. È un’idea terribile».
Anni fa lei disse in un’intervista che Internet avrebbe cambiato le cose in modo molto radicale. È stata profetica, visto quel che è successo con la primavera araba. Ritiene che ci siano altri elementi che possono contribuire al cambiamento?
«La rete ha dimostrato di essere utile e dobbiamo proteggere la sua libertà. Wikileaks insegna. Quanto al resto, è nella natura degli esseri umani desiderare la libertà. È dentro di loro, un istinto insopprimibile che li spinge a fare le loro decisioni».
Anarchica e femminista:non crede però che la libertà sessuale si sia trasformata in un boomerang per le donne, totalmente mercificate nella nostra società?
«Ogni buona idea si può corrompere. Il femminismo non è un’eccezione. Questo non vuol dire che prostituirsi sia un crimine: le carceri sono piene di prostitute e di drogati, ma dovremmo parlare di problemi piuttosto che di crimini».
Judith Malina, lei ha un sogno?
«Certo! La bella rivoluzione anarchica non violenta. Il cambiamento che porti a una città organizzata e più umanitaria. Come diceva il grande anarchico Alexander Beckman è questione di organizzazione, organizzazione e ancora organizzazione».
Tratto da «L’Unità», 12 luglio 2011