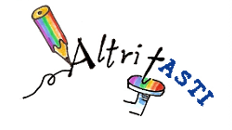Ai piedi dello sperone roccioso inizia il ripido declivio della sella erbosa.
Ai piedi dello sperone roccioso inizia il ripido declivio della sella erbosa. E’ primavera avanzata, l’erba non è ancora bruciata dal sole perché riesce a trovare ancora nelle chiazze di neve residuale l’acqua che altrimenti precipiterebbe immediatamente a valle.
Una femmina di camoscio è isolata dal piccolo branco di altre femmine, nascosta dietro un enorme masso protagonista di erosioni antiche.
E’ distesa a terra, ansimante per la fatica ed il dolore quale mai aveva provato. Non percepisce il sole nascente e caldo che trapassa i gendarmi affilati, non sente il vento attraversagli il pelo invernale da dismettere, è rassegnata a raccogliere il testimone dalla sua genitrice per dare alla luce un nuovo esemplare di acrobata della roccia ...
Da ore lo sta attendendo, sola, perché così vuole la specie, al riparo da occhi indiscreti, soprattutto quelli che, volteggiando in cerchio centinaia di metri sopra di lei, sarebbero pronti a ghermire.
Un belato rauco, adulto, prima intermittente e poi continuo rompe il digiuno di rumore, gli altri esemplari alzano distrattamente la testa per protendere le narici al vento, non sono spaventati dalla voce di un loro simile, soltanto meccanicamente reagiscono con il comportamento consueto dell’attenzione al pericolo.
Distrattamente, nel lento brucare a distanza, accolgono il nuovo venuto, praticamente afono, traumatizzato dall’esplosione di luci ed odori.
La ruvida lingua della madre massaggia il suo corpo ancora infagottato nella placenta per liberarlo dagli ultimi vincoli del suo grembo e consegnarlo ripulito ed asciutto alla montagna. Ormai il sole è alto, ha superato definitivamente gli ostacoli delle cime e può dedicare la sua luce diretta per salutare l’ingresso alla vita di un cucciolo di camoscio.
Malconcio e malfermo, i primi movimenti rispondono all’istinto di ergersi in piedi, ma solo per pochi istanti, perché una improvvisa frenesia lo assale, ogni muscolo del suo corpo è in tensione per dare alla sua testa pesante la forza di cercare tra bordi taglienti di roccia e soffice pelo accogliente il capezzolo ristoratore, il legame, la continuità, la sicurezza.
Mamma camoscio è generosa a concedersi nonostante la stanchezza, la fame, la sete, nonostante abbia il desiderio di tirarsi in piedi, di sgranchirsi le zampe magari con una folle corsa sulla cengia esposta; generosa a lasciarsi prosciugare dalle prime nervose ed inesperte poppate.
Il piccolo è ormai definitivamente un camoscio, guidato dall’autorevole presenza della sua mamma, ora più severa nell’indicargli che è tempo di muoversi, di raggiungere il resto del gruppo.
La sua nascita è stata salutata dall’aquila, cui non è sfuggito l’evento, che dall’alto con le sue grida stridenti mette in allarme la vallata intera, ma per il piccolo non è ancora tempo di avere paura, senza accorgersene si ritrova tra le zampe della madre, ancora riparato dal suo ventre ormai flaccido, oscurato alla vista dal corpo materno.
Questo succede in un giorno di maggio, in quota, dove i pochi esseri umani che vogliono arrivarci possono essere facilmente evitati, controllati a distanza. Questo succede in un ambiente scarso ed essenziale, povero e rigido, dove i sentimenti ed i pensieri non possono essere complicati. Questo succede in un luogo di evidente contraddizione tra la solitudine degli spazi e l’accoglienza del cuore.
In questo tempo, in questi luoghi il piccolo esordisce, sono passate poche ore ed il ritmo frenetico iniziale si è spento nel sonno. Troppe fatiche, troppi stimoli ed emozioni, per questo ha abbandonato i riflessi nervosi dell’apprendimento e si è accasciato sul materasso di erba finalmente rilassato.
Sarà la sua prima notte esposto al vento gelido che arriva dal ghiacciaio, vedrà la prima notte illustrata dal chiarore delle stelle, appena disturbate dai vortici intermittenti dei cirri. Sarà spesso svegliato dal passaggio di ombre repentine, ora generate dal transito delle nubi nel cono di luce della luna, ora generate dal furtivo movimento di lepri delle alpi; apprenderà ad essere vigile e sensibile a luci e rumori anche durante il sonno.
Questa è la storia di Jumpy.
Un camoscio con un nome inglese, sarà pure strano, ma così fu chiamato ed oggi raccontato da chi ebbe la fortuna di conoscerne la storia.
Furono due alpinisti inglesi a battezzarlo. Un giorno, all’attacco di una via, videro il camoscio un tiro più in alto, gli zoccoli piantati su una minuscola cengia, videro il giovane camoscio che li osservava per nulla spaventato.
Con un paio di balzi in discesa senza fermarsi ma lasciandosi scivolare dalla forza di gravità giunse quasi vicino a loro incuriosito dagli abiti evidenti, dalle corde multicolori, dal rumore di ferraglia appesa alle imbragature.
“Jump” esclamò uno degli alpinisti e l’animale accogliendo l’invocazione riprese la sua posizione iniziale risalendo con la stessa facilità con cui era sceso.
“Jump” ancora, e lui saltò ancora più in su, superò un camino sfidando la legge di gravità e si rese invisibile da sotto poggiandosi su un terrazzino sporgente.
Lo rividero solo al termine della via, quando in cima, finalmente liberatisi dalle sicure, sentirono alle loro spalle il suo respiro rauco.
I suoi occhi fissavano uomini, altrettanto animali.
I suoi occhi pareva dicessero: “benvenuti, welcome”. Un benvenuto che vuol dire condivisione, un benvenuto per insegnare che nello spazio ristretto della cima ognuno trova accoglienza.
“Jumpy, it’s your name” gli dissero gli alpinisti, ridendo, anzi sorridendo, perché l’umore divertito venne polverizzato da un violento raggio di sole. Una fiammata di luce accese di riflessi le roccette sommitali, fino a prolungarsi oltre la catena della valle successiva, fino a delineare i contorni minacciosi di una perturbazione ancora per fortuna lontana, prima di degradare con strisce d’ombra dietro il profilo della catena opposta.
Jumpy non seguì il ritorno degli alpinisti, la loro discesa illuminata dalle lampade frontali fu orfana di questo accompagnatore, scelse invece un altro percorso per raggiungere i compagni già addormentati. Per la prima volta aveva avvicinato degli uomini, strani animali che gli anziani del branco dipingevano come pericolosi, traditori, violenti. A lui invece erano sembrati solo deboli.
Deboli e impacciati nella ricerca della traccia utile per salire, deboli per il loro terrore di cadere nel vuoto.
Non si immaginava come li si potesse temere quando impiegavano ore per percorrere il tratto che lui avrebbe potuto compiere con quattro balzi misurati, non poteva considerarli violenti vedendoli aggrappati alla parete con le braccia doloranti e trafelati a recuperare le forze per superare l’ennesimo ostacolo.
Sentiva le loro voci rieccheggiare ancora nel canalone ripido di discesa, trasportate dal vento le parole si scioglievano in puro suono, la loro casa, il loro rifugio notturno era ancora lontano, molto più in basso, nella valle, dove l’acqua invece di precipitare scorreva.
Da quel giorno Jumpy non perse occasione di accompagnare lo sforzo degli uomini che cercavano le cime. Quando li scorgeva a distanza, come puntini animati arrancare tra le morene e percorrere i tornanti faticosi dei sentieri, smetteva il ruolo solitario del maschio procreatore per convertirsi in un tutore. E per gli uomini, o per meglio dire, per coloro che affrontavano per pura passione il mondo verticale, Jumpy divenne una guida. La sua presenza rassicurava, riusciva a trasformare l’ambiente statico, spigoloso e ruvido della roccia, in un quadro animato ricco di sorprese e di diversità.
La sua indifferenza nell’affrontare i punti più esposti aiutava a gestire le esplosioni di adrenalina provocate dai passaggi limite, dove solo la superficie minima delle dita sosteneva un corpo altrimenti destinato a cadere alla base del colatoio.
Poi il suo belato, nei giorni in cui improvvisamente la montagna scompariva nelle nuvole, diventava il punto di riferimento per occhi inutilmente protesi ad individuare i confini dello spazio.
A valle Jumpy divenne una leggenda.
Il lago, da dove partiva il lungo sentiero di avvicinamento, nei giorni afosi d’estate si popolava di gente, attorno alle sue sponde le auto erano ammassate disordinatamente, ognuna a tutelare un piccolo quadrato di erba sul quale sistemare il tavolino da pic-nic. I giochi rituali del pallone disturbavano ma contemporaneamente erano complementari alle posture immobilizzate per l’abbronzatura. Questa era la valle, popolata e colonizzata dagli odori di carne bruciata, rumorosa e invadente. Eppure, eppure, quando dal sentiero, anticipate dal rumore dei ferri di salita, le sagome degli alpinisti al ritorno dall’impresa comparivano, tutti interrompevano le inutili stereotipate attività per correre da loro e farsi raccontare di Jumpy.
Raccolti in cerchio ascoltavano affascinati le evoluzioni generose di un animale innamorato dell’uomo. Così i racconti alimentavano la leggenda.
Come quando la cordata, sfiancata dalla fatica e dal freddo stava desistendo, le corde doppie pronte per una discesa precipitosa e Jumpy comparve sulla loro stessa sosta e con gli occhi velati di delusione implorò loro di non mollare, di non deludere il sogno di qualche ora prima. Sporgendo il muso annusò il vento, lo inspirò tutto e la cima apparve, appena pochi metri sopra di loro, visibile in uno squarcio tra le nuvole nere di rabbia come un quadro retroilluminato.
Oppure quando un solitario alpinista aprendo una nuova via si trovò bloccato, incapace di proseguire. Per ore rimase a cercare un impossibile passaggio senza riuscirvi, fino a che la comparsa di Jumpy gli indicò l’unico punto debole della montagna da attaccare e .. vincere.
Passarono i mesi, passarono gli anni, ma la fama di Jumpy continuava ad essere alimentata dai racconti di chi tornava. Nessuno si preoccupava di quanto tempo fosse passato, di quanto fosse inverosimile, incompatibile il tempo trascorso con la durata della vita di un camoscio.
Sempre più gente raggiungeva lì, veniva sperando di poter ascoltare la storia di un nuovo incontro, per immaginare prima e sognare poi, per un bisogno di salire, almeno con la mente, in luoghi dove assieme al pericolo ed alla fatica ci si può anche concedere il lusso di essere ininfluenti, dipendenti.
Un giorno dal sentiero sbucò l’ennesimo alpinista, subito la folla lo circondò in silenzio: era ormai una prassi, era codificato che chiunque tornasse dalla montagna dovesse fare un resoconto dell’incontro con Jumpy.
Questa volta però il silenzio non si ruppe. L’alpinista era anziano, forse vecchio quanto Jumpy, le rughe scavate dal tempo erano annerite dall’esposizione ai violenti raggi solari dell’altitudine, le sue mani erano artigli scarnificati dalle prese appuntite e taglienti della roccia, i suoi capelli bianchi, perennemente offesi dal vento sembravano un cespuglio di mirtilli.
Il vecchio si fermò impossibilitato a muoversi dal cerchio muto ed ansioso della gente, a sua volta in silenzio.
“Allora? Jumpy? Non ci dici niente?”
Il vecchio indirizzò lo sguardo verso la direzione dove la voce anonima aveva finalmente rotto il silenzio.
“Jumpy non c’è, Jumpy non esiste”.
Bastò questa affermazione per disorientare la gente come potrebbe fare un rumore improvviso e lancinante. Il vecchio alpinista non si curò della delusione apparsa sui volti di tutti, non tentò di mantenere in vita, fingendo, la leggenda. Si voltò indietro a guardare la montagna appena scalata e ripercorse a ritroso le tracce evidenti di sentiero proprio fino alla fine: fino ad incontrare la punta dei suoi scarponi. Con lo sguardo abbassato e gli occhi bloccati tra le stringhe usurate, fece un passo deciso per fendere la folla, ruppe il cerchio e se ne andò volgendo le spalle alla delusione degli astanti. Ma, nonostante fosse voltato, tutti poterono ascoltare la sua voce pronunciare con chiarezza, prima di scomparire tra le baite:
“Jumpy siamo noi, se solo lo volessimo....”.