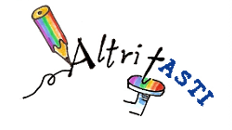di Sergio Labate.
Mio figlio – d’improvviso e senza apparenti motivi – ha deciso di amare il calcio. Non posso far molto: ha sei anni e tutto il diritto di rovinarsi la vita come crede. Ma decisamente non è il periodo migliore per un simile colpo di fulmine. Tra un mondiale che non ci prova nemmeno a nascondere la contraddizione sanguinaria del capitalismo da cui è nato e un’indagine giudiziaria che scopre la presunzione ontologica del discorso del capitalista: rendere il profitto una sostanza più reale del principio di realtà. Eppure, poiché anch’io ci sono cascato da piccolo, rimango affascinato dal modo in cui le espressioni dell’amore calcistico siano cambiate. Perché il calcio non è affatto uno specchio deformato della realtà, è piuttosto uno specchio nitidissimo di una realtà in sé già deformata. Per questo conviene prestargli attenzione: è attraverso questo specchio che possiamo cogliere in modo eminente alcune patologie sociali...
Per esempio, mi rendo conto che mio figlio non è attratto dal gioco in sé o dalla tecnica che porta al gol. Ciò che lo colpisce di più è poter ripetere la ritualità del gesto dell’esultanza. Ognuno ha ormai il suo modo di esultare, ciò che trasforma un calciatore in un brand. Io non ricordo l’esultanza di Maradona ma ho memoria dei suoi gol, mentre mio figlio non ricorda i gol ma sa perfettamente quale sia “la mossa di Cristiano Ronaldo”. Perché proprio il gesto dell’esultare? Certo, perché esso si può ripetere uguale a se stesso ogni volta, mentre non si può segnare sempre lo stesso gol. Come tutti i riti, la forza sta nel suo carattere iterativo. Ma non tutti i riti sono uguali e se ogni società ha bisogno dei suoi riti, ogni società si definisce per i riti che sceglie di officiare. E il rito calcistico dell’esultanza è quanto di più eloquente possibile: tutti i gesti sono studiati per essere estremi, per fissare quell’istante in un’istantanea che lo assolutizza, lo rende memorabile, unico. La gioia pura del compimento dell’azione – quella che provo io stesso quando riesco a ultimare un lavoro – può ormai essere vera solo se si manifesta come esperienza dell’eccesso. Non abbiamo altro modo di godere che non sia questa brutale eccitazione. Nulla più della ritualità dell’esultanza calcistica ci educa alla società eccitata, come la definiva Türke in un suo celebre libro. La sua tesi era interessante, perché individuava il carattere proprio del nostro tempo precisamente nella ricerca compulsiva del “sensazionale”. Ecco, la pedagogia neoliberale dell’esultanza è quella per cui una felicità “normale” non esiste se non assume in qualche modo la forma del “sensazionale”. Per cui il delirio prestazionale si sposta: la prestazione non consiste tanto nel fare le cose ma nel trasformarle in qualcosa di sensazionale. Il campione non è colui che vince, ma chi è maestro di questa felicità sensazionale: di chi insegna a stare al mondo nel tempo della società eccitata.
C’è un commentatore tecnico dei mondiali – un ex calciatore non particolarmente brillante – che esprime perfettamente questa missione che trasforma il calcio in un dispositivo neoliberale. Ogni gesto ben fatto non può essere descritto nei suoi termini – appunto: “ben fatto” – ma deve subito essere enfatizzato. Un semplice rigore segnato dà luogo alla ritualità dell’eccitazione: è tutto un urlo, una retorica teologica («trasforma l’acqua in vino»), un uso ridondante di metafore ed espressioni volte sempre a caratterizzare la prestazionalità di qualcuno nei termini dell’unicità. Nessuno può più essere bravo come gli altri (o tra gli altri), ma per essere bravi bisogna essere unici, bisogna vincere contro gli altri. E dunque quell’eccitazione diventa la sensazione dell’odio, del “farcela da soli nonostante gli altri”. Sarebbe interessante studiare le forme predominanti delle esultanze calcistiche: esultanze tribali (i compagni che danzano all’unisono), esultanze di ostilità o di sfoggio della potenza (la mossa pavoneggiante di Cristiano Ronaldo), esultanze familistiche (mimare il pancione o il ciuccio, ricordare i parenti morti). Tutto rimanda a una sensazionalità che diventa misura del nostro successo e del grado di soddisfazione che possiamo ottenere.
È inutile ricordare che l’ombra necessaria della società eccitata è la società depressa. L’eccitazione non è una durata, è un picco. A cui seguirà inevitabilmente il tempo dell’astinenza. Il sensazionale non permette altre sensazioni oltre di sé. Così la fatica di essere noi stessi sarà inevitabilmente coinvolta in quest’alternanza di sensazioni estreme: o esultare o essere vani. O esibirsi o essere nessuno. O vincere e odiare o perdere ed essere odiati. Il calcio pretende di sostituire il criterio aristotelico del giusto mezzo. E noi – non solo la generazione di mio figlio – siamo in trappola, incastrati dentro questo modello di società in cui il problema non è, come vorrebbe un discusso parlamentare della sinistra, rivendicare il “diritto all’eleganza” (che in questo caso si potrebbe tradurre come il “diritto all’esultanza”). Il problema è che oggi “essere come Cristiano Ronaldo” non è affatto un diritto, è piuttosto un dovere. La vita dei campioni che esultano ai mondiali sarà dentro una privilegiata società eccitata, quella di mio figlio che riproduce il loro rito introiettando le aspettative prestazionali sarà probabilmente dentro una società bipolare.
Ora, perché racconto tutto questo e non parlo di ciò che sta accadendo in Qatar e alla Juventus? Perché credo che stia parlando della stessa cosa. Beninteso, la cosa cui mi riferisco non è il calcio, è il capitalismo. C’è un argomento che spesso viene usato dai pasdradan del neoliberismo. È l’argomento secondo cui il problema della società contemporanea non è l’eccesso di autonomia del mercato dalla società, ma il contrario: il fatto che comunque vi sia – sempre di meno eppure inevitabile – un residuo di società irriducibile al mercato. Che vi siano ancora condizionamenti sociali e politici al meccanismo autoregolatorio. Un rovesciamento distopico della realtà, evidentemente. Ecco, basta vedere il documentario sulla Fifa che è disponibile in questi giorni su Netflix per capire che il calcio rappresenta, allo stato attuale, una formidabile zona franca in cui quella distopia può dispiegarsi in tutta la sua radicalità. L’anticipazione della società che i guardiani della rivoluzione neoliberista vorrebbero. Un luogo in cui non vi sono vincoli politici e il potere è gestito solo in funzione dell’accumulazione del capitale.
Che accade in un luogo così, che si autocomprende come zona franca da ogni controllo e da ogni responsabilità sociale? Un luogo in cui l’autoregolazione del mercato giunge al punto che persino il valore economico è soltanto una forma e come tale può contestare qualunque sostanza, come nel caso delle plusvalenze juventine? La distopia neoliberale può così essere messa in scena: le imprese calcistiche partecipano a un mondo che per definizione attraversa i confini della sovranità statale, che si fanno letteralmente giustizia da sé (avendo delle “magistrature autonome”), in cui la ricerca del profitto diventa il metro esplicito della disputa sul potere: chi domina, domina perché accumula per sé e per gli altri e questa è l’unica legittimazione che basta per decenni e decenni, in sfregio a qualunque criterio democratico di giustificazione.
Ciò che accade nel calcio è semplicemente ciò che accade quando il capitalismo prende possesso di ogni angolo della società. Non c’è mano invisibile, ma le mani visibilissime di coloro che elargiscono mazzette e modificano bilanci senza alcun controllo. E lo fanno con il disprezzo di chi sta in alto e pretende che chi sta in basso lavori perché possa continuare la festa dei pochi. La faccia tosta e le mani sporche di chi seppellisce dentro lo spettacolo dei mondiali migliaia di schiavi morti per l’accumulazione dei pochi, ma anche la faccia tosta di chi trucca i bilanci e si scaglia contro lo Stato colpevole di non farsi i fatti suoi (e negli stessi giorni però chiede aiuto, perché non è una contraddizione: è lo spirito stesso dell’accumulazione lasciata misura del mondo). È soprattutto la faccia tosta di chi pretende che quella distopia non sia un gioco elitario, ma diventi la forma dell’intero mondo. E così insegna a mio figlio che se gioca è perché deve esultare. Se vale, è perché deve brandizzarsi.
È proprio ora che io smetta di scrivere, e lui di guardare i mondiali. Adesso cercheremo insieme un piccolo spazio di prato dove mettere una porta e far rotolare una palla. E imparare a correre. Perché bisogna imparare a correre, per poter lasciarsi alle spalle questa misura del mondo.
Sergio Labate è professore di Filosofia teoretica presso l’Università di Macerata. Tra i sui temi di ricerca ci sono il lessico della speranza e dell’utopia nell’età secolarizzata, la filosofia del lavoro, le passioni come fonti dei legami sociali, la difesa della democrazia costituzionale nell’epoca del suo disincanto generalizzato. È presidente di Libertà e Giustizia. Tra le sue pubblicazioni: “La regola della speranza. Dialettiche dello sperare” (Cittadella 2012), “Passioni e politica” (scritto insieme a Paul Ginsborg, Einaudi 2016), “La virtù democratica. Un rimedio al populismo” (Salerno editrice 2019).
Tratto da: https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/12/13/il-calcio-e-lo-specchio-della-societa/