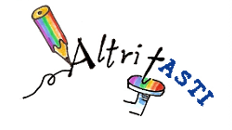di José Saramago.
L’uomo più saggio che ho conosciuto non sapeva né leggere né scrivere. Alle quattro della mattina, quando la promessa di un nuovo giorno ancora indugiava sulla terra di Francia, egli si alzava dal suo giaciglio e andava nel campo, per dare da mangiare alla mezza dozzina di maiali la cui fertilità nutriva lui e sua moglie. I genitori di mia madre vivevano in questa povertà, sulla piccola prole dei maiali che dopo lo svezzamento veniva venduta ai vicini nel nostro villaggio di Azinhaga nella provincia del Ribatejo. I loro nomi erano Jerónimo Meirinho e Josefa Caixinha ed erano entrambi analfabeti ...
Durante l’inverno quando il freddo della notte cresceva fino al punto di gelare l’acqua nei recipienti all’interno della casa, essi andavano nel porcile e prendevano i maialini più gracili e li portavano nel loro letto. Sotto la rozza coperta, il calore umano salvava i piccoli animali dal congelamento e li strappava a una morte certa. Sebbene i due fossero persone gentili, non era un’anima compassionevole che li induceva ad agire in quel modo: quello che li interessava, senza sentimentalismo o retorica, era proteggere il loro pane quotidiano, come è naturale per persone che, per mantenersi la vita, non pensano ad altro che all’indispensabile. Molte volte ho aiutato mio nonno Jerónimo nel suo lavoro di pastore, molte volte ho vangato la terra nell’orto della casa e ho spaccato la legna per il fuoco, molte volte, facendo girare e girare la grande ruota di ferro che muoveva la pompa, raccoglievo acqua dal pozzo della comunità e la portavo sulle spalle, molte volte, di nascosto dalle guardie dei campi, andavo con mia nonna, anche all’alba, armato di rastrello, sacco e corda, a spigolare le stoppie, la paglia sciolta che serviva da lettiera per il bestiame. E qualche volta, nelle notti calde d’estate, dopo cena, mio nonno mi diceva: “José, questa notte andiamo a dormire, tutti e due, sotto il fico”.
C’erano altri due alberi di fico, ma quello, certamente perché era il più grande, perché era il più vecchio, era da sempre per tutti nella casa, il fico. Più o meno per antonomasia, una parola erudita che incontrai solo molti anni dopo e ne imparai il significato... Nella pace della notte, fra gli alti rami dell’albero una stella mi appariva e poi lentamente si nascondeva dietro una foglia, mentre, guardando in un’altra direzione, come un fiume che scorre silenziosamente per il cielo concavo, sorgeva la opalescente luminosità della Via Lattea, la Via per Santiago, come ancora siamo soliti chiamarla nel villaggio. Quando il sonno tardava, la notte era popolata da storie ed eventi che mio nonno raccontava: leggende, apparizioni, terrori, episodi singolari, antiche morti, zuffe con bastoni e pietre, parole dei nostri antenati, un’instancabile chiacchiera di memorie che mi tenevano sveglio, e nello stesso tempo mi cullavano.
Non potevo sapere se egli smetteva di parlare quando si accorgeva che ero caduto addormentato, o se continuava a raccontare per non lasciare a mezzo la risposta che io invariabilmente facevo nelle pause più lunghe che egli appositamente metteva nel racconto: “E poi?”. Forse egli ripeteva le storie per se stesso, come per non dimenticarle, o anche per arricchirle con nuovi dettagli. A quell’età, come noi tutti facciamo, non c’è bisogno di dire che immaginavo che mio nonno Jerónimo fosse padrone di tutte le conoscenze del mondo. Quando alle prime luci dell’alba, il canto degli uccelli mi svegliava, egli non era più lì, era andato nel campo con i suoi animali lasciandomi dormire. Allora io mi alzavo, piegavo la rozza coperta e scalzo (nel villaggio io sempre camminavo scalzo fino all’età di quattordici anni) e con la paglia ancora infilata nei capelli, andavo dalla parte coltivata del campo all’altra parte, dove c’erano i porcili, a lato della casa. Mia nonna, già in piedi prima di mio nonno, mi metteva davanti una grande scodella di caffè con pezzi di pane e mi chiedeva se avevo dormito bene. Se le raccontavo qualche brutto sogno che proveniva dalle storie del nonno, ella sempre mi rassicurava: “Non farci caso, nei sogni non c’è nulla di solido”. A quel tempo pensavo che, se pure mia nonna fosse una donna saggia, non poteva sollevarsi alle altezze di mio nonno, un uomo che, giacendo sotto un fico, avendo al suo fianco José, il suo nipote, poteva mettere in moto l’universo con solo due parole. Fu solo molti anni dopo, quando mio nonno se ne andò da questo mondo e io ero un già un uomo fatto, che finalmente giunsi a comprendere che mia nonna, dopo tutto, credeva anche lei nei sogni.
Non ci poteva essere altra ragione perché, sedendo una sera davanti alla porta della sua povera casa dove ora ella vive da sola, indicando le più grandi e le più piccole stelle sopra la sua testa, dicesse queste parole: “Il mondo è così bello, ed un peccato che si debba morire”. Non diceva paura della morte, ma peccato di morire, come se la sua dura vita di incessante lavoro, in quel momento vicino alla fine, stesse ricevendo la grazia di un supremo e ultimo addio, la consolazione della bellezza rivelata. Era seduta davanti alla porta di una casa come nessun’altra posso immaginare nel mondo, perché in essa viveva gente che poteva dormire con i maialini come se fossero figli propri, gente che era molto dispiaciuta di uscire dalla vita proprio perché il mondo è bello; e questo era Jerónimo, mio nonno, pastore di porci e raccontatore di favole, che sentendo arrivare la morte, andò a dire addio agli alberi nella corte, uno per uno, abbracciandoli e piangendo perché sapeva che non li avrebbe più rivisti.
Molti anni dopo, scrivendo per la prima volta su mio nonno Jerónimo e mia nonna Josefa (non ho detto che ella era, secondo molti che la videro quando era giovane, una donna di non comune bellezza), fui alla fine consapevole che stavo trasformando delle persone comuni quali esse erano, in personaggi letterari, e che questo probabilmente era un modo di non dimenticarli, disegnando e ridisegnando i loro volti con la matita che sempre cambia la memoria, colorando e illuminando la monotonia di una routine quotidiana bassa e priva di orizzonte, quasi per creare, sull’instabile mappa della memoria, una realtà sovrannaturale del paese nel quale decisero di vivere. La stessa attitudine mentale che, dopo avere evocato l’affascinante ed enigmatica figura di un certo nonno berbero, mi portò a descrivere più o meno con queste parole una vecchia foto (ora sono quasi ottanta anni) mostrante i miei genitori: «Entrambi sono in piedi, belli e giovani, di fronte al fotografo, mostrando nel volto un’espressione di solenne serietà, forse timore, davanti alla macchina fotografica, proprio nel momento in cui la lente sta per fissare, dell’uno e dell’altra, un’immagine che non tornerà mai più, perché il giorno seguente sarà, implacabilmente, un altro giorno... Mia madre appoggia il suo gomito destro su un alto pilastro, e tiene, nelle mano sinistra che cade lungo il corpo, un fiore. Mio padre ha il braccio attorno al corpo di mia madre, e la sua mano callosa appare sopra la spalla come un’ala. Essi sono in piedi, timidi, su un tappeto con disegnati dei rami. Il quadro che forma lo sfondo simulato della fotografia mostra diffuse e incongrue architetture neoclassiche.»
E terminai: «Verrà il giorno in cui dirò queste cose. Nulla di ciò importerà se non a me. Un nonno berbero dal Nord Africa, un altro nonno pastore di maiali, una bellissima nonna; genitori belli e seri, un fiore in una foto – di quale altra genealogia potrebbe importarmi? E a quale miglior albero io potrei appoggiarmi?» ...
José Saramago. Dalla lettura per il Premio Nobel, 7 dicembre 1998.