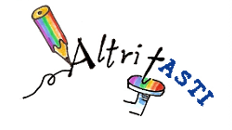Che cosa significa, davvero, integrazione? Ne parliamo tanto, ma cos’è che definisce una persona che pure conserva vive e presenti le caratteristiche della sua cultura d’origine, come integrata in una società in cui non è nata e cresciuta?
Che cosa significa, davvero, integrazione? Ne parliamo tanto, ma cos’è che definisce una persona che pure conserva vive e presenti le caratteristiche della sua cultura d’origine, come integrata in una società in cui non è nata e cresciuta?E chi fa parte della cultura che riceve persone provenienti dall’esterno, non deve o non si trova obbligatoriamente, per necessità, per curiosità, per l’incontro con nuove idee ed abitudini, a doversi a sua volta integrare con coloro con cui entra in contatto?
L’integrazione è un cammino in una direzione sola (come molti per comodità, timore, egoismo, pretesa di supremazia dei propri modelli culturali, desidererebbero), o non è piuttosto un processo osmotico e di fatto l’obbligatorio risultato dell’incontro di due mondi?
Con noi lavora una donna rom. Quando è arrivata, credo ormai cinque anni fa, nonostante fossimo solite lavorare con donne di svariate nazionalità, qualche timore l’avevamo ...
Diciamolo chiaramente, nel nostro immaginario collettivo ancestrale, a rubare gli ori e i bambini, a lanciare maledizioni oscure e a somigliare alla streghe, non sono i neri, i sudamericani o i cinesi: sono gli zingari, acquattati ad un angolo di strada ad allungare cantilenando una mano che già ci sembra contenere un inganno.
Quando gli zingari, colorati e volatili come mazzi di preghiere tibetane, salgono su un mezzo pubblico e si spargono come scoiattoli, tutti, più o meno a ragione, ma istintivamente, mettiamo la mano sulla borsa e vediamo, se gli siamo vicini, di evitare, per vari motivi, contatti fisici.
Così, quando sul grande treno multi–esperienziale della nostra cooperativa è salita Vesna, anche se già conoscevamo la sua storia, fatta di coraggio e di scelte difficili da affrontare, per i primi tempi siamo rimaste ad osservarci reciprocamente: lei ad abituarsi all’ambiente e al nuovo lavoro e noi a vedere se con una donna rom era poi tanto più difficile intendersi piuttosto che con un’altra persona.
Perché, quello che non ci facilita le cose con i rom, rispetto al contatto con altre etnie, sono i secoli di estrema prossimità fisica e di altrettanta distanza nelle abitudini di vita: alla fine non abbiamo fatto altro che condividere per centinaia di anni gli stessi spazi, concependoli ed usufruendone in maniera totalmente diversa.
E guardando Vesna in quei primi tempi di reciproco avvicinamento, mi sono resa conto di quanto fosse più fiera e disinvolta quando era sola, come se in lei qualcosa, che si nascondeva per inveterata abitudine di fronte alla nostra presenza, si risvegliasse non appena pensava di non essere osservata, si rialzasse e ritrovasse il suo naturale posto nel mondo.
Ma a poco a poco, la natura di Vesna ha imparato a fidarsi di noi e noi di lei e dell’enorme sforzo che doveva rappresentare per quella donna che aveva perso precocemente il marito in un incidente d’auto, uscire ogni mattina dal campo, in cui già aveva lottato per mettere in riga i cinque figli e mandarli a scuola, venire in un mondo estraneo, vivere una nuova vita e poi tornare nella sua comunità, dove rappresentava un’anomalia e dove doveva mantenere un’autorevolezza, contatti quanto più possibile buoni con gli altri membri e insegnare una nuova vita ai bambini, senza per questo staccarli dalle proprie tradizioni.
Un compito enorme, una specie di titanica doppia vita che spesso a noi non è dato capire fino in fondo, sia per le difficoltà della lingua, sia e soprattutto per la diversità delle nostre storie e delle nostre vite: molte volte le sue opinioni e le nostre, dopo essersi incontrate, rimangono le stesse, sconcertate per di più, di fronte a quanto hanno ascoltato.
Io personalmente non ho simpatia per le società tradizionali, dove spesso donne, bambini e stranieri vengono pesantemente discriminati e non appartengo alla categoria di coloro che cercano le loro radici: penso che sarebbe meglio essere semi fertili, che fatto tesoro del patrimonio che portano in nuce dentro di sé, si preparano ad una nuova terra e ad un nuovo mondo.
Nemmeno mi piace la parola “tolleranza”, perché trovo bruttissimo essere “tollerati” da qualcuno: semplicemente, quando non capisco, se non posso far altro, mi fermo e ne prendo atto, in attesa di approfondire.
E’ quello che ho fatto più volte di fronte ad opinioni di Vesna che cozzavano contro le mie, soprattutto per quanto riguarda l’educazione delle figlie femmine: ho capito che il fatto di farle sposare prestissimo, rappresentava per lei una forma di tranquillità sociale, il vederle protette dal loro ruolo di mogli e di madri, ma continuo a provare pena per le bambine nate in società che applicano questo tipo di ragionamento e niente modifica le mie impressioni.
Credo che a sua volta Vesna applichi in eguale misura lo stesso concetto nei nostri confronti e che le sia difficilissimo approvare determinati nostri comportamenti, ma che sia più sincera di noi quando afferma che a questo mondo siamo in tanti e diversi e ognuno deve accettare gli altri e trovare il suo posto: lei d’altronde, “i tanti e i diversi”, girando tutta l’Europa in fuga dalla guerra, li ha conosciuti e noi, spesso no.
Vicini e lontani: ecco come siamo noi e i rom, e mai completamente consapevoli dei reciproci pensieri, dei simboli, dei ragionamenti che passano dietro le nostre fronti mentre ci guardiamo diffidenti o tentiamo di comprenderci.
Eppure, più di una volta in questi anni, Vesna mi è sembrata mia “parente”, più di tanti altri nati e cresciuti nella mia stessa società: parlando con lei mi è parso di ascoltare nonne e zie che uno spostamento temporale avesse trasportato, ancora giovani, nel duemila.
Era lo stesso modo materno, emotivo, carico di pathos, di malinconica nostalgia e di improvvisa allegria nell’affrontare la vita; era come parlare con qualcuna vissuta due generazioni indietro, ma profondamente familiare, conosciuta da sempre. La stessa voglia di chiacchierare tra donne, di parlare di bambini, di raccontare fatti antichi e cose di ogni giorno, di condividere segreti e di litigare da un balcone all’altro. Cose perse, in gran parte, nella nostra vita così cambiata, così veloce e attiva, così intellettuale, ma custodite con cura in ognuna di noi e subito pronte a riemergere e a farsi riconoscere appena evocate.
Ma che qualcosa di veramente nuovo fosse avvenuto, fosse cresciuto silenziosamente tra i gesti e i discorsi di ogni giorno, ho cominciato ad intuirlo la scorsa estate.
C’erano tre vasi da fiori vuoti nel cortile di fronte alla biblioteca, tre vaschette rettangolari trascurate nella fretta delle mille priorità affannose di ognuna di noi.
Un giorno, in uno di quei vasi, è spuntata una pervinca, timida e solitaria.
“E questo bel fiore da dove arriva?”
“L’ho piantato io” ha detto Vesna “ è brutto lasciare i vasi vuoti.”
“Hai proprio ragione: prenderemo altri fiori.”
Ma a dire il vero, non li abbiamo presi e l’inverno si è portato via la pervinca.
Questa primavera i vasi erano ancora lì e la terra, secca.
“Ancora questi vasi vuoti!” ha commentato Vesna e in due riprese li ha riempiti di bellissime viole e di surfinie dai colori squillanti.
“Quanto ti dobbiamo?”
“Niente. I fiori li metto io, li ho anche a casa” ha risposto lei con semplicità: perché quando una donna fa queste cose, ovunque si trovi, è chiaramente a casa.
A volte l’integrazione è un vaso di viole, che fiorisce sereno sul davanzale di una finestra.