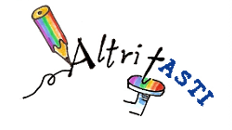di Paolo Cacciari.
Una delle caratteristiche che a me sembra costitutiva del sistema di relazioni capitalistiche è la bipartizione dell’essere umano in produttore e consumatore. Una separazione all’interno dello stesso individuo. Una dissociazione tra homo faber e homo consumens e il progressivo slittamento della centralità del sistema dalla “società dei produttori” a quella dei “consumatori” ...
Nel capitalismo dei consumi il lavoro vivo subordinato eterodiretto viene programmaticamente e progressivamente escluso dalle decisioni su cosa e per chi produrre. Questo potere è posto in capo esclusivamente all’imprenditore.
Ma nemmeno esso è davvero “libero”. Semplicemente è stabilito che l’apparato produttivo sia chiamato a produrre ciò che il sistema di mercato è in grado di distribuire e collocare. «Anche il capitalista è asservito al dispositivo della valorizzazione secondo una modalità che si autoalimenta. Egli è impegnato a valorizzare il valore nello stesso modo in cui riproduce la produzione» [1].
Apparentemente si tratta di un meccanismo impersonale, automatico, persino “naturale”, in grado di equilibrarsi spontaneamente. I manuali insegnano che il mercato è in equilibrio generale quando i saggi di sostituzione nell’uso di tutte le merci scambiate uguagliano le ragioni di scambio (i prezzi e i costi) fra le merci.
In verità, meno astrattamente, il sistema di mercato porta a produrre quelle merci per le quali vi sono consumatori solvibili, buyers con un potere d’acquisto sufficiente a remunerare i costi di produzione delle merci e i relativi profitti.
L’individuo produttore recupera un potere di decisione su cosa produrre solo indirettamente, quando e nella misura in cui gli viene concessa la libertà di scegliere cosa comprare.
Il rapporto di lavoro salariato deresponsabilizza (aliena) il produttore: pane o cannoni, fa lo stesso. Già Marx descriveva bene l’assoluta indifferenza del capitale verso il valore d’uso delle merci, per il loro contenuto intrinseco.
Nella rappresentazione che fornisce di se stesso, il sistema economico capitalistico è come se intendesse abdicare volontariamente dal decidere cosa produrre a favore dei suoi “clienti”; gli acquirenti. Così, a maggior ragione, anche il “prestatore d’opera” deve rinunciare a prendere parte alla decisione su cosa, quanto, dove, per chi produrre. Al massimo al lavoratore è concessa la possibilità di esprimere la propria opinione sul “come” produrre per gli effetti diretti che ciò ha sulle proprie condizioni di lavoro.
Quel che solo conta è che la prestazione lavorativa sia compensata da un (più o meno) dignitoso corrispettivo monetario.
Il discorso vale per l’organizzazione produttiva nel suo insieme. Nella società capitalistica, l’impresa produttiva è – non a caso – definita dagli ordinamenti giuridici come a “responsabilità limitata”. La sua missione sociale è specifica: produrre a costi e in tempi sempre minori una quantità sempre maggiore di merci da collocare sul mercato.
La “domanda” diventa così l’oracolo sacro. Poco importa se è pubblica o privata, individuale o collettiva, di beni o di servizi, di cose materiali o immateriali, di organi da trapiantare o di uteri di donne povere da collocare in affitto. L’importante è che la domanda solvibile cresca in continuazione. L’apparato produttivo – come l’intendenza negli eserciti – seguirà e si adeguerà corrispondendo le forniture richieste, gli oggetti, le mercanzie realizzabili in termini di valore monetario.
Il consumo, nel discorso corrente, diventa così il “principe” del sistema. Cosa e quanto produrre deve apparire come dipendente solo dalle “preferenze” del consumatore solvibile. Si dice che la società capitalistica sia la più liberale tra quelle comparse nella storia dell’umanità proprio perché lascia ai singoli individui la libertà di scegliere cosa utilizzare e consumare. Peccato che prima debbano riuscire a possederli.
I sistemi di governo conseguenti – le market democracies – sono quelli che si adoperano per lasciare ai cittadini la libertà di scegliere come consumatori. Chiunque voglia interferire sul libero gioco che si instaura tra domanda e offerta limita le libertà degli individui.
Tutto, nelle società capitaliste, appare assolutamente semplice, ragionevole, efficiente. «Il “populismo di mercato” – scriveva Zygmunt Bauman [2] – considera il mercato come lo strumento democratico più affidabile (se non addirittura l’unico possibile)».
Non prendetevela, quindi, con l’imprenditore e tantomeno con i suoi dipendenti se il sistema economico produce cose che fanno male alla salute, che sono poco etiche o che inquinano l’ambiente, che non servono a nulla o, semplicemente, che funzionano male!
La “colpa” non è loro, ma di tutti noi che in quanto acquirenti (consumatori/utenti/elettori) non siamo capaci di orientare l’offerta esprimendo una preferenza e selezionando così le merci offerte sui mercati dei beni di consumo, dei servizi, della politica e di imporre al sistema di produrre cose diverse, più utili, più sane, più durevoli, più belle…
Si è così potuta affermare l’ideologia illusoria del consumatore sovrano che vota comprando. Perché, si dice e si ripete in continuazione: “nel mercato libero sono i consumatori finali ad avere l’ultima parola”.
É certo importante giocare anche la carta del consumo consapevole e responsabile, ma – come vorrei dimostrare in seguito – non penso che lo scontro di classe possa traslocare dalla fabbrica al supermercato. Sarebbe un errore speculare a quello commesso dal movimento operaio nella tradizione novecentesca (scusate l’approssimazione) che pensava che la “contraddizione principale” potesse risolversi agendo solo nel luogo di lavoro direttamente produttivo.
A me pare che i termini della questione non siano così lineari.
In realtà – come sostiene sempre Bauman – il consumo più che un atto di libertà, di autoaffermazione e di piacere, è un atto obbligatorio e di sottomissione all’ordine sociale. Per alcune ragioni che provo ad elencare.
I consumatori non sono tutti uguali e non hanno lo stesso peso sul mercato. C’è chi è più solvibile e chi non riesce nemmeno ad entrare nel mercato. Un terzo della popolazione mondiale ne è escluso e costituisce l’immenso esercito di riserva che serve a tenere negli stretti limiti della sussistenza un altro terzo della popolazione mondiale che lavora per fornire a buon mercato beni e servizi al rimanente terzo.
E, in quest’ultimo terzo privilegiato, c’è chi riesce ad accumulare plusvalenze e chi invece deve indebitarsi per far fronte alle proprie esigenze vitali.
Il gioco del libero mercato, quindi, non appiana le differenze, ma aumenta le iniquità. Le disuguaglianze sono il motore del mercato. Come è facile immaginare, il relativo “potere dei consumatori” (derivante dalla loro mitica “libera scelta”) è molto diversificato, dipende dal loro potere d’acquisto.
Chi ha più denaro da spendere è in grado di influenzare e indirizzare l’offerta più di quanto non lo riesca a fare chi non ha i denari necessari per soddisfare i propri bisogni elementari. Questi ultimi saranno sempre costretti a indirizzare le loro scelte di consumo sulle merci più economiche, più scadenti, meno sane e, molto probabilmente, con una maggiore impronta ecologica e un maggiore carico di sfruttamento lungo la catena produttiva.
Ci ricorda Benjamin R. Barber che il sistema di mercato è più interessato a «vendere beni superflui a chi se li può permettere, piuttosto che a produrre beni necessari per chi non ha i mezzi per poterli acquistare» [3].
Non solo. Il “peso” dei diversi insiemi di consumatori dipende anche dal modo con cui ottengono il denaro che spendono. I top manager, gli amministratori delegati, i detentori delle rendite finanziarie e terriere, gli azionisti e quant’altri girano attorno a loro riuscendo ad ottenere super prebende (grandi burocrati, grandi professionisti, opinionisti e politici al seguito) indirizzeranno i loro consumi verso i segmenti del lusso, a più alta profittabilità.
All’opposto, la possibilità di influenzare il sistema produttivo da parte della gente comune, in quanto consumatori poveri, è pressoché inesistente. Persino quando è un “piccolo risparmiatore” la sua voce nelle assemblee di bilancio e nei consigli di amministrazione delle società di capitale e nelle banche è – quando va bene – ridotto ad un potere di tribuna.
In definitiva – a costo di dire una grossa banalità – in una società classista, a decidere cosa, quanto, dove e per chi produrre saranno sempre le classi superiori, detentrici di maggiore potere economico e di strumenti di direzione dall’alto.
Detto tutto ciò al solo scopo di evitare il rischio di cadere nella trappola del mito bugiardo del consumatore padrone delle sorti della società, è certo necessario e possibile aggredire l’Idra dalle mille teste anche dal lato del “consumo”, usando i margini di potere di scelta che sono nelle mani del consumatore consapevole e responsabile. Soprattutto nelle economie più opulente e sature di merci, dove il sistema produttivo fa sempre più difficoltà a collocare le sue mercanzie.
Le enormi spese bruciate in pubblicità (stimate a livello mondiale tra i 500 e i 600 MLD di $ all’anno. 276 MLD di $ solo negli Stati Uniti nel 2005, che dovrebbero rappresentare la metà della spesa mondiale, secondo Barber), stanno a dimostrare queste difficoltà.
Grazie ai progressi tecnologici oggi è più facile (ed economico) produrre che vendere. Il profitto più “evoluto”, lungo la catena della produzione del valore, è generato dal marketing, dal branding, dal packaging, dalla ideazione del prodotto. La concorrenza tra le imprese nei mercati più redditizi si combatte sempre di più sull’immagine simbolica del marchio, sul suo “capitale di reputazione”.
Pertanto, le imprese più orientate sui generi di consumo sono sensibili alle campagne di informazione sui loro comportamenti (vedi le varie iniziative sulla Responsabilità sociale e ambientale delle imprese). Oggi anche i fondi di investimento speculativi si auto-attribuiscono bollini di eticità, legalità, ecologismo. Da quest’anno entrano in funzione per le grandi società le norme della Direttiva europea sul bilancio di sostenibilità (DNF, Dichiarazione di carattere non finanziario). Un report sugli aspetti ambientali e sociali delle imprese.
C’è già chi pensa di certificare “l’impronta etica” delle imprese. La competizione avviene sempre di più sul versante della reputazione. “Noi non vendiamo cose – dicono i maghi del marketing – facciamo sognare la gente”.
Mi pare molto giusto e forte ciò che Agostini e Mezza scrivono: «Consumare significa attribuire significato agli oggetti […] un agire sociale dotato di senso. Consumare non è altro che il modo attraverso cui gli esseri umani costruiscono se stessi, la loro identità e le loro relazioni sociali» [4].
Un buon modo per attivare il potere del consumatore sul sistema produttivo mi pare quindi quello di oltrepassare la condizione di acquirente e rivendicare una posizione di potere decisionale sulla intera filiera produttiva. I sociologi ci insegnano che il consumatore è destinato a rimanere perennemente infelice, altrimenti il soddisfacimento incepperebbe la riproduzione delle condizioni per la generazione di sempre nuovi consumi.
Lo aveva già capito Thomas Hobbes nel Leviatano: «La felicità è un continuo progredire del desiderio da un oggetto ad un altro, non essendo il conseguimento del primo che la via verso il seguente». Il consumo in una società che ha come fine la crescita perenne non deve essere mai bastevole, sufficiente.
I modi per uscire da questa spirale cieca sono due: smettere di consumare (gli obiettori, i disertori o, semplicemente, i “consumatori imperfetti” sono in aumento) o, paradossalmente, prendere sul serio e sfidare il mito del “consumatore sovrano” pretendendo di estenderlo oltre la falsa concorrenza tra i prodotti (in realtà tutti uguali) esposti a portata di mano sugli scaffali dei supermercati o sui siti ebay.
Si potrebbero ipotizzare “consumatori attivi” in grado di rivendicare clausole sociali e ambientali da imporre alle imprese produttrici (trasparenza e tracciabilità lungo tutte le filiere), non solo per sé, ma nell’interesse di tutti i produttori della Terra, la nostra casa comune. Così da restituire dignità al lavoro di chi produce e sostenibilità ecosistemica nell’utilizzazione del patrimonio naturale (molto impropriamente definito “capitale naturale”) e dei prelievi delle risorse non rinnovabili.
In questo modo si verrebbe ad instaurare un patto tra acquirenti e produttori tale da abbattere la separazione schizofrenica che il sistema capitalistico ha creato tra lavoratore e consumatore (e abitante), ognuno dei quali dovrebbe badare al proprio interesse particolare e contrapposto all’interno delle regole del mercato: il primo dovrebbe pensare solo ad ottenere una maggiore retribuzione, il secondo ad avere merci a più basso costo.
Rompere i ruoli “sindacali” pre-assegnati e liberarsi dai paraocchi culturali del consumismo dovrebbe costituire il tracciato di una convergenza nelle pratiche dei movimenti dei lavoratori e dei consumatori.
Capisco che una differenza dei ruoli è in larga misura inevitabile, poiché non tutti sappiamo fare tutto, e una divisione delle competenze è necessaria, ma non deve diventare contrapposizione di interessi.
Vi sono molte esperienze positive di persone che avviano percorsi di ricomposizione dell’unità del loro essere. Dovremmo essere guidati da una visione di società formata da individui interi, pieni, integrali. Diceva Romano Alquati, un esponente della vecchia guardia dell’operaismo di Quaderni Rossi: «gli operai sono uomini interi, non solo mani e stomaci». E Alain Caillé, nella Critica della ragione utilitaria ha scritto: «Gli uomini sono uomini prima di essere lavoratori e le società sono umane prima di essere macchine per produrre».
Dovremmo quindi cercare di costruire una umanità cosciente e responsabile delle proprie azioni nell’arco di tutte le sue funzioni vitali, esigenze, pulsioni. Un percorso di recupero delle libertà d’iniziativa di ogni individuo. Un processo – certo non facile – di liberazione dai condizionamenti e dalla etero direzione, dalla sovraimposizione.
Rimane del tutto aperta la questione culturale gigantesca sul modo in cui le persone possono riuscire ad acquisire una coscienza di sé attraverso l’acquisizione e l’utilizzo delle cose di cui hanno bisogno. É evidente che si tratta di un processo di introspezione profondo, di messa in discussione di pratiche e consuetudini che richiede un lavoro sui propri desideri, sul significato che ognuno attribuisce alle cose.
Il consumo – ci dicono una schiera di antropologi, psicologi sociali e psichiatri – è una fonte di godimento. Lo shopping è un cerimoniale, una forma rituale. Le merci sono le cose «nell’universo fantasmatico del simulacro», che hanno come esito la «cosificazione delle persone [trasformate in] oggetti passivi» (Esposito). Il consumismo compulsivo è una condizione patologica di miseria psichica. Ovvero, un processo di “infantilizzazione” (Barber).
A me pare che una buona idea per innescare un processo concreto di cambiamento sia quella del cittadino e della cittadina “prosumer” (crasi tra pro-ducer e con-sumer): produttore e consumatore assieme. Mi pare che in questa direzione vadano molte esperienze di acquisto collettivo (Gruppi di acquisto solidale, empori gestiti dai distretti dell’economia solidale, mercatini a filiera corta…), di commercio equo (circuiti delle Botteghe del mondo, di Altro Mercato, delle charity…), di autoproduzione (orti sociali, ciclofficine, laboratori in co-working…), di autoproduzione energetica (tetti fotovoltaici in cooperativa…), di mutualità e auto-aiuto (Banche del tempo, welfare di prossimità, microcredito, commonfare…), di CSA (comunità urbane di sostegno all’agricoltura), di economia collaborativa e della condivisione (le mille forme di sharing economy favorite dalle piattaforme digitali).
Tutte relazioni economiche in cui il cittadino viene considerato non solo come cliente passivo (target delle politiche di marketing), ma come compartecipe alle scelte di politica economica e industriale.
Un altro possibile sentiero lungo il quale il consumatore attivo e consapevole potrebbe trovare il potere di incidere sulle politiche pubbliche e orientare il modello stesso di società è quello dei “beni comuni”. Negli ultimi anni si è diffuso a livello mondiale un movimento che ha riscoperto il valore dei commons. Grazie a studi economici e storici come quelli della premio Nobel Elinor Ostrom, alle proposte di giuristi come Stefano Rodotà e Ugo Mattei, a storici come Peter Linebaugh, ad antropologi e sociologi come David Bollier, Silke Helfrich, Massimo De Angelis, Carlo Donolo, Silvia Federici e, principalmente, alla spinta di movimenti popolari come quelli per l’acqua, per la neutralità della Web, per l’autoproduzione dei semi e contro la brevettabilità dei genomi vegetali e animali, per la libera circolazione dei saperi e per l’accesso ai beni pubblici… il concetto di “bene comune” è entrato nel discorso politico corrente.
La sua definizione giuridica rimane problematica, ma la sua forza evocativa e politica è evidente. Vi sono dei beni che per ragioni naturali (le risorse e i servizi ecosistemici che la natura ci fornisce gratuitamente) o per lascito della storia umana (i prodotti del lavoro e della creatività delle generazioni che ci hanno preceduti) non possono essere privatizzati, escludenti.
La loro gestione deve corrispondere a criteri di equità, universalità e di preservazione. Sono, in definitiva, res communes omnium, res extra mercatoria, appartengono alla collettività.
I beni comuni, al fondo, sono un’istanza di democrazia. Ha scritto Peter Barnes: «Ognuno di noi è il beneficiario di un’immensa eredità che include aria, acqua, habitat ed ecosistemi, lingue e culture, scienza e tecnologie, sistemi sociali e politici e un sacco di altre cose (…) La ricchezza comune è la materia oscura dell’universo economico: è dappertutto, ma noi non la vediamo perché non ha etichette con il prezzo” [5].
Per il movimento dei consumatori saper riconoscere e rivendicare questi beni è un modo per sottrarre al sistema delle grandi compagnie transnazionali le risorse di base su cui basano il loro dominio economico e, quindi, restituire ai “consumatori” un potere decisivo sulla loro utilizzazione. Allargare la sfera dei beni e dei servizi pubblici – il più possibile gestiti in autonomia dalle comunità di riferimento – è un modo per rovesciare la piramide delle gerarchie di potere attribuendo agli utilizzatori finali, consumatori-utenti-gestori, un ruolo davvero centrale nelle decisioni su cosa, quanto, come, dove, per chi… produrre.
Note
1 Roberto Esposito, Le persone e le cose, Einaudi 2014, p.59
2 Zygmunt Bauman, Homo consumens, Erickson 2007, p.39
3 Benjamin R Barber, Consumati. Da clienti a cittadini, Einaudi 2010, p. 73
4. L. Agostini e M. Mezza, Riflessioni sul futuro della Federconsumatori e del consumerismo, in “Ti con zero. Note critiche”, n.27, 2017
5 P. Barnes, Capitalismo 3.0. Il pianeta patrimonio di tutti, Egea, 2007
Tratto da: https://comune-info.net/2017/12/consumare-in-modo-diverso-consumo/