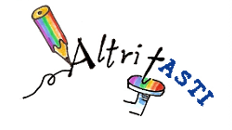Sempre nel 2015, una ricerca Censis-Rbm calcola in oltre 11 milioni (coinvolto il 43% delle famiglie italiane) le persone che hanno dovuto rinviare o rinunciare a cure mediche adeguate, a causa delle difficoltà economiche.
Nel medesimo anno, come in tutti gli anni precedenti, lo Stato ha pagato 85 miliardi di euro solo per gli interessi sul debito pubblico.
C’è connessione fra queste cifre? Chi dice di no non ha mai fatto parte né della categoria della povertà assoluta, né di quella che fatica a curarsi adeguatamente. E’ per questo che considera il debito pubblico italiano come essenzialmente dovuto alla dissennatezza collettiva dell’aver vissuto per anni “al di sopra delle proprie possibilità” e trova ora normale doverne pagare lo scotto (interessi compresi), sapendo che ricadrà su ben precise fasce di popolazione.
Ma è andata davvero così? Naturalmente no e pochi dati bastano a dimostrarlo.
Negli ultimi 20 anni, il bilancio dello Stato si è chiuso in avanzo primario (rapporto fra entrate e uscite) per ben 18 volte e la parte dei cittadini che ha sempre pagato le tasse ha versato allo Stato almeno 700 miliardi di euro in più di quello che ha ricevuto sotto forma di beni e servizi.
Come mai allora il nostro debito continua a veleggiare oltre i 2.200 miliardi di euro? Perché dal divorzio fra Ministero del Tesoro e Banca d’Italia nel 1981, e la conseguente fine della copertura “in ultima istanza” da parte di quest’ultima dei prestiti emessi dallo Stato, gli interessi da pagare sul debito sono saliti alle stelle, tanto che ad oggi abbiamo già collettivamente pagato oltre 3.000 miliardi di interessi su un debito che continua a salire e che auto-alimenta la catena, ingabbiando la vita e i diritti di tutti.
La spesa per interessi è pari a oltre il 5% del Pil e rappresenta la terza voce di spesa dopo la previdenza e la sanità. Se a tutto questo aggiungiamo il fiscal compact, ovvero l’impegno preso in sede europea a riportare il rapporto debito/Pil dall’attuale 130% al 60% nei prossimi venti anni, con un taglio conseguente della spesa pubblica di circa 50 miliardi/anno, il quadro della trappola diviene evidente: il debito serve a trasferire risorse dal lavoro al capitale e a consegnare ai grandi interessi finanziari, attraverso alienazione del patrimonio pubblico e privatizzazioni, tutto ciò che ci appartiene.
E la sottrazione di democrazia messa in campo con la riforma costituzionale, sulla quale si voterà in autunno, rappresenta solo il tentativo di approfittare della crisi per approfondire le politiche liberiste, sostituendo la discussione democratica con l’obbligo alle stesse e il necessario consenso con la collettiva rassegnazione.
La trappola del debito diviene ancor più evidente se poniamo l’attenzione sugli enti locali e le comunità territoriali, ormai giunti al collasso finanziario, grazie al combinato disposto di patto di stabilità (e pareggio di bilancio), tagli ai trasferimenti e spending review: quanti sanno infatti che, nonostante il contributo degli enti locali al debito pubblico italiano sia pari solo al 2,4%, sugli stessi si sia scaricata la maggior parte delle misure, al punto che dal 2008 i tagli delle risorse a loro disposizione siano passati da 1.650 a 15.500 miliardi (+900%) ?
Di fronte a questi dati, possiamo continuare a dire che il debito è ineluttabile e a considerare gli interessi sullo stesso normale parte del contratto stipulato?
Possiamo continuare a pensare che il debito, in quanto colpa, va saldato e trovare normale che a quella cultura si educhino intere generazioni già nella scuola, con la trasformazione dei giudizi sull’apprendimento in “debiti” e “crediti”?
Crediamo di no e, a sostegno d questa tesi, basta leggersi l’art. 103 della Carta dell’Onu, quando pone l’obbligo di ogni Stato a garantire pace, coesione e sviluppo sociale sopra ogni altro e qualsivoglia impegno contratto dallo stesso.
Del resto, qualcuno può ritenere sostenibile mantenere un debito, che oltre allo stesso, comporti la sottrazione annuale di 135 miliardi di euro di risorse collettive, per pagarne gli interessi e per adempiere al fiscal compact?
Da che mondo è mondo, non si è mai visto un creditore anelare al pagamento del debito. L’usuraio teme due soli eventi nella sua “professione”: la morte del debitore e il saldo del debito, perché, in entrambi i casi, perderebbe la fonte periodica del suo sostentamento –gli interessi- e la possibilità di dominio sull’altro e sulle sue scelte in merito ai suoi averi e proprietà (nel caso degli Stati, i beni comuni).
Ecco perché il debito deve smettere di essere un tabù e deve divenire parte concreta delle battaglie per un altro modello sociale. Se il debito è oggi agitato come “lo shock per far diventare politicamente inevitabile, ciò che è socialmente inaccettabile” (Milton Friedman), occorre che le popolazioni passino dal panico prodotto dallo shock –che comporta paralisi, ripiegamento individuale e adesione alla narrazione dominante- alla sana pre-occupazione, ovvero alla capacità collettiva di iniziare ad occuparsi di sé, della collettività e del comune destino.
Rifiutando la trappola del debito e rivendicando a tutti i livelli –locale, nazionale e internazionale- la necessità di un’indagine indipendente e partecipativa che sveli quanta parte del debito è illegittima e quanta parte è odiosa –dunque da non pagare- e che affronti, partendo dall’incomprimibilità dei diritti individuali e sociali, tempi e modi del pagamento dell’eventuale restante parte legittima.
Di tutto questo se ne discuterà all’università estiva di Attac Italia, a Roma dal 16 al 18 settembre, in una serie di seminari che, partendo dal debito internazionale (con la presenza di Eric Toussaint del Cadtm), arriverà a mettere a confronto le nuove esperienze di movimento e istituzionali nelle “città ribelli” di Barcellona, Napoli e Roma ( http://www.italia.attac.org/index.php ).
Un’occasione per liberare il presente e riappropriarci del futuro.